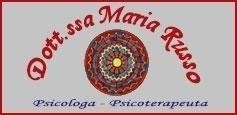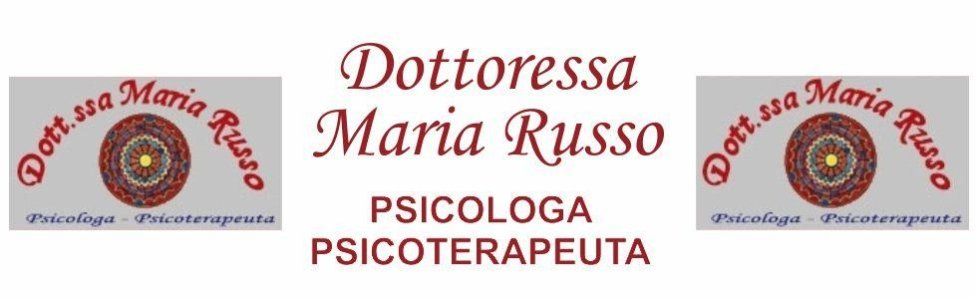Studi, casi clinici, contributi di ricerca e approfondimenti.
Qui trovate alcune delle pubblicazioni e degli articoli della dottoressa Russo.
Formazione ed esperienza
Il percorso formativo ed analitico e la lunga esperienza clinica sono alla base delle prestazioni di qualità elevata in ambito psicologico clinico e psicoterapeutico.
La sua continua formazione, nei numerosi settori della psicologia le permette di approcciarsi con professionalità alle differenti problematiche psicologico cliniche e psicopatologiche.
Comunicazione sulla salute
Dai problemi adolescenziali alla psicologia sociale, dalle sedute individuali ai gruppi, la dott.ssa Maria Russo è in grado di aiutarvi a superare i momenti difficili.
I suoi studi sulla comunicazione sulla salute le hanno permesso di specializzarsi nel campo medico, dove offre sostegno ai malati terminali e a chi si trova ad accudire malati di Alzheimer.

null
GIORNATA DI STUDIO
GLI OPERATORI DELLA SALUTE
E I PROCESSI COMUNICATIVI
Agrigento 28 giugno 2007
Via Imera n. 85
Per una Babele comunicativa: il linguaggio tecnicistico nei contesti di cura
Dr.ssa Maria Russo
Narra la leggenda che Nimrod, un fedele cacciatore al servizio di Dio, dopo aver sconfitto in battaglia gli eserciti dei discendenti di due dei figli di Noè, cominciò la costruzione, della città di Sennaar. Egli, divenuto un arrogante sovrano, decise di sfidare Dio per vendicare la morte dei suoi avi annegati da Jahve durante il Diluvio Universale. Intraprese, dunque, la costruzione di una torre, superiore in altezza al monte Ararat, la Torre di Babele, nell’ambizioso obiettivo di condurre un esercito contro Dio e di salvarsi se quest’ultimo avesse deciso di sommergere ancora il mondo con un altro diluvio. Nimrod si illudeva, così, di poter distruggere Dio, per mettere al suo posto i suoi idoli. Intanto i lavori procedevano così alacremente da far diventare gli stessi operai cinici ed arroganti, tirandosi dietro le invettive e la maledizione di un certo Abramo. Così, quando la costruzione non era ancora ultimata, l'esercito di Nimrod ebbe l'ordine di scagliare le proprie frecce dalla sommità della torre contro il cielo; gli angeli di Dio raccolsero i dardi uno a uno per ingannare gli uomini ed in luogo di essi lasciarono cadere delle gocce di sangue. I presuntuosi arcieri esultarono all'unisono, nell’irreale convinzione di aver ucciso tutti gli abitanti del cielo. Dio, allora, convocò i settanta angeli che lo circondavano al Suo cospetto e disse loro: «Scendiamo tra loro e confondiamo il loro linguaggio, in modo che invece di una sola lingua essi ne parlino settanta». Così fecero e i costruttori cessarono di capirsi. Non fu loro più possibile interpretare correttamente gli ordini impartiti, ciascuno parlò una lingua differente, fondò le proprie città e nazioni e non riconobbe più nessun capo comune. Dio mandò, infine, i settanta angeli a sorvegliare quelle nazioni ma si riservò di sorvegliare egli stesso i figli di Abramo che per suo volere restarono fedeli alla lingua ebraica.>>
Il linguaggio, quale veicolo di conoscenza ed espressione, attuato
<<tramite segni intersoggettivi in grado di significare altro da sé>> (Galimberti, 1992)
è il terreno su cui, da alcune decine di millenni, si dispiega la sfida che dell’essere umano fa un animal simbolicum ed ancor oggi il termine babele viene utilizzato con una connotazione decisamente negativa poiché adoperato come sinonimo di “insieme caotico e confuso di linguaggi”.
In un secolo fortemente connotato dall’ipercomunicazione tecnicistica e multimediale, la controparte psichica, o l’acting, messi in atto da noi operatori della salute è una rischiosa forma di babelistica incomunicabilità intra ed interdisciplinare. E’ dunque con imponente incisività che si presenta, il tema problematico della relazione operatore/operatore ed operatore/utente, mediata dai differenti linguaggi, marcatamente tecnicistici, utilizzati dalle numerose professionalità operanti nei contesti di cura, in un’epoca di vorticosi cambiamenti, in cui
<<l’etica celebra la sua impotenza nel mondo della tecnica regolato dal fare come pura produzione di risultati […]. Ciò significa che non è più l’etica a scegliere i fini e ad incaricare la tecnica di reperire i mezzi, ma è la tecnica che, assumendo come fini i risultati delle sue procedure, condiziona l’etica, costringendola a prendere posizione su una realtà che la tecnica non cessa di costruire e rendere possibile […]. Nel monologo collettivo proprio dei tempi più recenti l’esperienza della comunicazione crolla, perché è abolita la differenza specifica tra le esperienze personali del mondo che sono alla base di ogni bisogno comunicativo>> (Galimberti U., 1999).
Per rimanere nella metafora biblica, il focus della mia relazione sarà centrato sulla babele di linguaggi tecnicistici simultaneamente utilizzati nei contesti di cura, all’interno dei processi comunicativi intercorrenti tra equipe pluridisciplinari, istituzioni, pazienti e familiari, area esplorata ed approfondita anche attraverso una ricerca/intervento, di tipo qualitativo a vertice psicodinamico, di cui tale contributo ne rappresenta la parziale resocontazione.
L’idea di tale ricerca è nata dall’incontro di due aspetti: da un lato l’aver appurato, attraverso un’attenta analisi dello stato dell’arte inerente la psicopatologia causata dalla comunicazione manipolativa nella società attuale, una produzione scientifica relativamente poco specifica in relazione all’incidenza dell’uso del linguaggio tecnicistico nei contesti sanitari, e, dall’altro, la ferma convinzione che proprio le differenze specifiche soggettive siano potenzialmente in grado di porre le fondamenta per un efficace lavoro d’équipe multidisciplinare, capace di concepire la differenza come risorsa. La lettura dei risultatati, come vedremo in seguito, ha attivato una serie di riflessioni su come il linguaggio specialistico eccessivamente tecnicistico, evidenziando le differenze intersoggettive, costringa spesso i membri della stessa equipe a mettere a confronto, temendolo, le identità personal-professionali, slatentizzando la tensione fra desiderio di distinguersi e di fondersi, fra bisogno più meno consapevole di proteggere la propria identità professionale e la possibilità di crescere nell’incontro con l’alterità.
La Finalità perseguita nella ricerca è stata l’esplorazione delle dinamiche relazionali e dei vissuti caratterizzanti gruppi di lavoro peculiari quali le équipe multidisciplinari; in particolare, il principale Obiettivo perseguito all’interno della ricerca è stato l’esplorazione della valenza che l’uso di termini troppo tecnici assume rispetto alla percezione degli operatori della Salute riguardo la propria identità professionale; inoltre si è indagato su come le difficoltà relazionali, causate e/o prodotte dall’uso di un linguaggio eccessivamente tecnicistico, possano vincolare la relazione con l’utenza, partendo dall’Ipotesi che l’uso di un linguaggio così peculiare da parte dei diversi operatori influenzi la qualità del lavoro di staff configurandosi come dispositivo difensivo ostacolante i processi comunicativi intersoggettivi. L’attributo difensivo non è qui utilizzato in un’accezione intrapsichica dei meccanismi di difesa, quanto facendo riferimento all’uso cristallizzato di uno “stile” difensivo che finisce per orientare la relazione patologizzando i contesti lavorativi. Non facciamo, dunque, riferimento ad una istanza riduttivamente intrapsichica, quanto ad un dispositivo facilitante/ostacolante la fondazione di pattern relazionali più o meno funzionali al contesto di riferimento. Per quanto riguarda la Rilevazione dei Dati, i Soggetti e gli Strumenti utilizzati, la ricerca/intervento ha coinvolto operatori di differente estrazione professionale (medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, psichiatri, ginecologi) operanti all’interno delle AUSL, del privato sociale e delle aziende ospedaliere, istituzionalmente <<costretti>> a riunirsi in équipe, spesso sporadicamente e con tempi molto veloci, per resocontare e condividere uno spazio al fine di perseguire obiettivi comuni. Gli Strumenti utilizzati sono stati il colloquio gruppale, i focus groups attuati mediante l’ausilio di attivazioni psicodrammatiche e l’osservazione all’interno delle riunioni periodiche d’équipe. L’Elaborazione dei Dati così raccolti, è stata attuata attraverso griglie qualitative costruite appositamente e l’uso di indici di statistica descrittiva. I Risultati costellano un quadro complesso, contraddistinto da una comune, ma taciuta, difficoltà a confrontarsi con professionalità diverse. Gli operatori manifestano, più o meno consapevolmente, una paura celata ma presente di perdere o con-fondere la propria identità professionale. Sembra difficile stabilire dei confini tra Sé ed Altro nell’istituzione (o forse proprio convivere nel topos del confine), se non quelli difensivi della chiusura o dell’uso di termini tecnici. Si è evinta, inoltre, un’impermeabilità alle risorse provenienti da professionisti differenti vissuti, come alcuni operatori affermano durante una delle attivazioni psicodrammatiche, come <<potenzialmente minacciosi rispetto alla stabilità della propria identità professionale>>. Ci è sembrato di poter legger, alla luce dei dati raccolti, l’uso di un linguaggio eccessivamente tecnico, dunque, come sistema di <<affermazione della propria identità nei sui aspetti più legati all’area dell’efficienza e del tecnicismo, polarizzata più sul versante dell’informazione e della chiusura, che della comunicazione e della condivisione>> (Russo et al. 2003 ). Dalle osservazioni attuate all’interno delle riunioni d’equipe, tale modalità si configura come rigida e spesso manipolativa, in quanto mira a creare delle posizioni rigidamente gerarchiche, per mettere ordine alla complessità della relazioni complementari proprie di un’équipe multidisciplinare, cadendo così nel circuito collusivo del concepimento/mantenimento di rappresentazioni di ruolo difensive e statiche. Tramite l’uso di linguaggio tecnico le equipe sembrano parlarci di una difficoltà di affidamento e condivisione con i colleghi, specchio di ansie legate a quelle aree emotivamente e/o affettivamente più investite. Con incisività, i focus group hanno messo in evidenza come tali dinamiche investano e influenzino la relazione con l’utenza, alla quale spesso viene proposto un modello relazionale e di intervento scisso e parcellizzato. I dati emersi attraverso i colloqui e le attivazioni psicodrammatiche hanno permesso di delineare una peculiare fisionomia degli operatori coinvolti, i quali appaiono impauriti di fronte alla vulnerabilità del sapere posseduto. Inoltre un’alta percentuale di essi sembra vivere la diversità professionale minacciosamente, un attentato al proprio essere ed alla propria professione, alle proprie certezze. Il confronto con i diversi operatori della salute pone un ulteriore interrogativo: la cosiddetta <<era della tecnica>> sta forse entrando in competizione, soppiantandola, con una più feconda pratica dell’ascolto di se stessi e degli altri? Non è frse vero che in ragione del nostro essere ginecologi, infermieri, assistenti sociali, psicologi o medici, noi tutti nella quotidianità facciamo ricorso ai sistemi di riferimento teorici ed al lessico specialistico relativi alla nostra qualifica professionale, così come anche nella vita extralavorativa disponiamo di referenti che orientano e guidano il nostro comportamento? Mi pare di poter affermare, alla luce dei dati emersi nella ricerca, che i suddetti paradigmi, però, frutto della sedimentazione delle esperienze precedenti di ognuno, spesso si rivelano funzionali entro un certo limite superato il quale appaiono impropri ed inadeguati. Come E. Borgna ci suggerisce,
<<nel linguaggio di ogni giorno si nascondono i significati che si perdono inesorabilmente quando ci rifugiamo, noi tutti…nel contesto di parole tecniche…parole desertiche che spengono ogni speranza>> Borgna 2001.
L’inarresatbile sviluppo tecnologico e proliferare di teorie scientifiche che ottimizzano i tempi e la qualità diagnostica e psicoterapica, nell’incalzante obiettivo di “curare” sembrano decimare la possibilità di “prendersi cura” del paziente e di se stessi. Le equipe coinvolte sembrano spesso dimenticare come non sia possibile prendersi cura degli utenti se non si compie,
<<quel gesto preliminare che si esprime nell’entrare in relazione con l’altro sulla linea di una emozionalità condivisa di una immedesimazione emozionale che prescinda da ogni rigida articolazione tecnica>> Borgna 2001.
Molti operatori coinvolti percepiscono i contesti lavorativi in cui sono inseriti in maniera ansiogena: essi temono che la propria individualità e la propria soggettività possa essere messa in discussione dall’eterogeneità professionale presente nelle equipe di appartenenza e vivono spesso la potenziale messa in luce delle proprie fragilità come una minaccia incombente di oscuramento della propria soggettività. <<Parlare di soggettività significa tirare in ballo il processo individuativo di ogni operatore che comporta una sorta di metabolizzazione della dimensione emotivo-affettiva da lui sperimentata sia nella vita privata che in quella professionale, che una volta interiorizzata è possibile esprimere a parole>> (Russo et al, 2003). Per mezzo dei colloqui e delle osservazioni periodiche all’interno dei gruppi osservati, sono emersi, i forti sentimenti di ambivalenza e di onnipotenza/impotenza, non di rado provati, nei confronti dell’utente (paziente, familiare del paziente) del proprio ruolo professionale, dei colleghi. Ambivalenza che, non essendo sempre vissuta consapevolmente, contribuisce all’attivazione di specifiche strategie difensive (quali ad esempio l’uso del linguaggio troppo tecnicistico) che consentono la sopravvivenza alla minaccia incombente di destrutturazione della propria identità professionale. Ed è da questa ontologica ambivalenza che inizia ad insinuarsi a poco a poco l’incertezza che porta a ricercare risposte certe in grado di dissetare la sete di conoscenze e la paura dell’ignoto. Gli operatori coinvolti sembrano protendere, come abbiamo sottolineato in altri contributi di ricerca, per la
<<scotomizzazione dal proprio campo psichico di tutti quegli elementi spiacevoli o frustranti che possono essere percepiti come intrusivi e pericolosi per la propria professionalità, l’allontanamento di spazi e tempi per vivere la relazione, e la rimozione della propria sfera affettiva-emozionale. In realtà così non solo si alza il rischio di burn-out dell’operatore, ma si preclude anche la possibilità di attingere all’importante risorsa delle proprie emozioni e vissuti soggettivi come principale canale per empatizzare con l’utente e quindi cogliere la sua sofferenza. Lasciarsi attraversare allora dalle proprie emozioni e riconoscere le proprie <<“ferite” diventa come nel mito di Chirone “il guaritore ferito”, l’unica condizione possibile per poter autenticamente entrare in una “relazione di cura” empatizzare con l’utente e compartecipare al processo di guarigione>>. Piazza A., Favoloro R., Russo M. 2002.
Sembra dunque di poter affermare, utilizzando un linguaggio junghiano, che per prevenire l’ipertrofia della tecnica e le estreme conseguenze ad essa interconnessa, sarebbe auspicabile la reintegrazione della polarità archetipale opposta alla tecnica e da essa scissa: l’anima. Tale locuzione è qui utilizzata nell’accezione proposta da Marcello Pignatelli, ovvero come capacità di individuare le strategie più appropriate e di concepire gli eventi della vita in continuo divenire mediante un approccio in grado di integrare la multidimensionalità dei fenomeni, ovvero le dimensioni razionale, affettiva, emotiva e relazionale, e di promuovere insight, contrastando il rischio di chiusura in una corazza tecnocentrica. Come l’autore segnala,
<<Ciò vuol dire esporsi al rischio di perdita e disorientamento, muovendosi lungo una linea di confine fluttuante, pronti a quella rottura, che consenta l’evoluzione dei punti di vista, tuttavia riferita all’essenzialità specifica della propria soggettività>>(Pignatelli M. 2002),
tenuto conto che <<la soggettività non è un dato di partenza, quanto piuttosto l’essere che diventiamo traversando la vita, nel racconto che di noi facciamo al /nel mondo>>Ravasi l., 2002.
Tra la Ricadute Operative vorrei segnalare il percorso esperenziale fatto con un gruppo pilota di operatori, che ha favorito l’opportunità di maggiori spazi di confronto e condivisione, facilitato l’elaborazione di alcuni conflitti e delle difficoltà ma anche una sintonizzazione ed una accoglienza di tempi, modelli, soggettività differenti. Il modello proposto all’interno del percorso ha offerto la possibilità e lo spazio interno per un confronto intersoggettivo, laddove il confronto presuppone ed impone la capacità empatica di riconoscere cosa riecheggia dell’altro dentro di noi e risuona di noi nell’interiorità dell’altro, correre il rischio di lasciarsi contagiare dalla sofferenza psichica, dalle paure dell’altro, sia esso un collega, unno, un paziente od un familiare. Ascoltare l’altro, il suo silenzio interiore al di là delle parole, ascoltarsi comporta, inevitabilmente una fatica ed sofferenza immane legata all’impatto che l’ascolto dell’ininterrotto fluire dei sentimenti e delle emozioni suscitano in noi. Ma è il prezzo da pagare per garantire prestazioni lavorative qualitativamente elevate, per il benessere personale e degli utenti, per impedire alla nostra interiorità di fossilizzarsi, inaridirsi, affievolirsi, per sperimentare se stessi ed alimentare la naturale sete individuativa di cui ognuno di noi è portatore. Il peculiare contributo della nostra ricerca consiste, dunque, nella proposta di un
<<modello clinico-terapeutico che opera un passaggio dalla dimensione del “curare a quella del “prendersi cura” in grado di superare le scissioni e le dinamiche di potere per giungere all’idea di una progettualità condivisa dall’intera equipe e quindi ad una ri-significazione del concetto di vincolo e di risorsa e di operare una cucitura nell’incontro/scontro tra identità professionale e personale lasciandosi attraversare e trasformare nella relazione con il paziente>>( Piazza A., Favoloro R., Russo M. 2002.)
Il gruppo pilota è stato effettuato tramite un modello psicodinamico, da qualche tempo in via di taratura, che presenta un setting formativo non privo di aspetti innovativi rispetto ai modelli tradizionali, in grado di coniugare le necessità individuali, “gruppali”, istituzionali e dell’utenza ormai sempre più esigente e consapevole del fatto che il principale indicatore di qualità del servizio erogato consista nella capacità di ascolto e presa in carico in toto dell’utenza da parte degli operatori d’aiuto. L’estremo contributo che la ricerca psicologica può dare a questo ambito di studio, partendo dal presupposto che le relazioni d’aiuto, sia che si tratti di terapie psicologiche sia che si tratti di terapie farmacologiche, sia che si tratti della relazione insegnante-alunno, presuppongono l’uso di un linguaggio intriso di affettività in luogo di un linguaggio specialistico, tecnico, è l’incessante invito ad accogliere la dimensione emotivo/affettiva propria ed altrui abbandonando l’uso improprio e cristallizzato di un linguaggio tecnicistico che offusca l’esistenza dell’intersoggettività, divenendo consapevole del timore latente di perdersi nell’incontro della soggettività dell’altro, abbandonando l’uso del linguaggio come scudo difensivo, manto di impenetrabilità in cui l’attraversamento di sé e degli altri diventa utopico, lasciando naufragare così ogni possibile comunicabilità. <<Nell’area della relazione interpersonale l’aprirsi e il chiudersi (la diastole e la sistole dell’anima) si alternano e si intrecciano; ma con il chiudersi (il richiudersi nei confini dell’io) interrompe la relazione, così l’aprirsi (l’espandersi) al di là di ogni misura rende precario, e problematico, l’articolarsi di un’autentica modalità d’incontro...anche il colloquio clinico non si svuota di significato se non quando ci sia il flusso continuo di esperienze e di contro esperienze fra il medico ed il paziente: nel contesto di questo aprirsi e di questo chiudersi emozionali; che abbiano a testimoniare di una inesauribile plasmabilità dei vissuti>>Borgna 2001. Bisogna avere il coraggio, parafrasando E. Borgna, di “sondare gli abissi”, riconoscere i limiti del nostro linguaggio, aprirci al confronto tra la propria e l’altrui formazione che influenza ogni possibile costituzione di senso poiché
<<non è possibile essere d’aiuto agli altri, e nemmeno essere d’aiuto a se stessi, se non si fa attenzione ai modi di essere del corpo vissuto: alle sue diverse espressioni; ed in particolare se non si fa attenzione a cogliere i significati che lampeggiano negli sguardi e nei volti delle persone>>. Borgna 2001.
L’esperienza “formativa” fatta con il suddetto gruppo pilota di operatori, ha dunque alimentato ed avvalorato l’ipotesi che una maggiore attenzione allo psichico possa riequilibrare il proprio agire professionale in funzione non degli sviluppi tecnici ma della capacità di anticipare gli effetti del proprio fare. Vorrei concludere auspicando, così, ad un operatore-prometeico (pro-metheus: colui che pensa in anticipo) e non “epimeteico” (colui che pensa col senno di poi) affinchè come “l’inventore delle tecniche” non si lasci soppiantare dalla tecnica che inesorabilmente accade, chiedendosi cosa ne farà la tecnica degli uomini, ma interrogandosi riflessivamente su quale uso della tecnica può promuovere benessere nei diversi contesti di cura, incarnando il ruolo di “operatore del dialogo”, capace di conversare e relazionarsi con l’atro da sé, e l’altra parte di sé, con la diversità, con l’ombra che l’altro (inteso come soggetto singolo e gruppale, il collega, il paziente, il familiare la patologia, etc), ci fa inconsapevolmente contattare.
Riferimenti Bibliografici
Borgna E., (2001), L’arcipelago delle emozioni, Feltrinelli, Milano.
Carotenuto A., (1990) “L’aquila di Prometeo”, in Le maschere dell’anima, Astrolabio, Napoli.
Galimberti U., (1999), Psiche e techné, Feltrinelli, Milano.
Galimberti U., (2001), La terra senza il male, Feltrinelli, Milano
Genesi, 3, 17-19 in La Sacra Bibbia, versione riveduta da Luzzi G., Società Biblica Britannica e foresteria
Guggenbhul-Craig A., (1983), (trad. it.), Al di sopra del malato e della malattia, Cortina, Milano, 1987.
Lingiardi V., Madeddu F., “I meccanismi di difesa. Teoria, valutazione, clinica”Cortina, Milano, 2002
Piazza A., Favaloro R., Russo M., “La relazione di aiuto nei contesti di emergenza sanitaria: una ricerca-intervento sulla relazione medico-paziente al pronto soccorso” in Atti del IV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica, Rimini, 2002.
Piazza A., Prestifilippo C., Tullio V., Guarire e/o curare e/o prendersi cura. Il processo di analisi della domanda in ambito sanitario, in V Congresso Nazionale Psicologia della Salute, Firenze, 2002.
Pignatelli M., (2002), “Il silenzio dell’anima” in Aite P. (a cura di) Eclissi della soggettività?,Vivarium, Milano
Russo M., Prestifilippo C., Longo B., Tutone A., Dalla multimedialità alla multidisciplinarietà:il linguaggio tecnicistico nel lavoro d’equipe I Congresso Nazionale “Medicina e Psicologia tra Terapia e Manipolazione.
Informazione e disinformazione sulla salute nello scenario della intermultimedialità”
Roma, 1-2-3 Ottobre 2003
Ravasi L., (2002), ”Sono qui nel mio lettino con me”, in Aite P. (a cura di) Eclissi della soggettività?,Vivarium, Milano
Trombini G. (a cura di), (1994) Come logora curare. Medici e psicologi sotto stress, Zanichelli, Bologna.

null
ELENCO PUBBLICAZIONI, CONTRIBUTI CONGRESSUALI E RECENSIONI
RECENSIONI
Russo M., “Il campo gruppale”,in GRUPPI, n1, genn-giugn.,’99
Russo M., “Valutare le psicoterapie, in GRUPPI, n1, genn-giugn.,’99
Russo M., “L’istituzione come sistema di gruppi GRUPPI, n 2, luglio-dicembre.,’99
Russo M.,La mente in internet” GRUPPI, n 2, genn-giugno 2000
Russo M., “Le teorie psicoanalitiche del gruppo”, GRUPPI, n 2,luglio-dicembre 2000
- Piazza A., Russo M., Tullio V., “Viaggiatori Bambini. Il Turismo come esperienza ludica: un contributo di ricerca”, in Atti del Convegno Nazionale “Risorse Umane e Sviluppo Turistico: Le NuoveProfessionalità in Europa”, Catania- Piazza Armerina, 20-23 ottobre 2000.
- Piazza A., Favaloro R., Russo M., “On the sea side of mediterranean, the process of <<Multicultural Relazional Citizen” in two harbour communities>>. in New Integration, Partnerships and Applications: Book of Abstracts (Zadarska Tiskara d.d., Zadar, 2001) – Regional Mediterranean Conference of IAGP “New Integration, Partnerships and Applications” Zadar, Croatia, 28 Agosto – 1 Settembre 2001;
- Russo M., Tullio V., “Stereotipi e Pregiudizi nella Formazione per i Soggetti a Rischio di Marginalità e/oViolenza: la Cittadinanza come Esperienza di Esclusione” in Atti del IV Convegno Nazionale AIP Sezionedi Psicologia Sociale - IV Convegno Nazionale AIP Sezione di Psicologia Sociale, Palermo 24, 25, 26 Settembre 2001;
- Russo M., “Psicodinamica della gravidanza: immaginario del parto e angosce di morte” in Atti del III CongressoNazionale AIP Sezione di Psicologia Clinica – III Congresso Nazionale AIP Sezione di Psicologia Clinica,Palermo 28, 29, 30 Settembre 2001;
- Russo M., Novembre M.R.., Zaoner L.,., “Per poter Rinascere: Modelli di Intervento Psicologico con Donne Mastectomizzate e Pazienti con Esperienza di Morte Perinatale Spontanea”-” in IV Congresso Nazionale AIP Sezionedi Psicologia Clinica – Riassunto delle Comunicazioni - IV Congresso Nazionale AIP Sezione diPsicologia Clinica Bellaria – Rimini, 13-14 Settembre 2002;
- Piazza A., Favaloro R, Russo M., ““La Relazione d’Aiuto nei Contesti di Emergenza Sanitaria: una Ricerca-Intervento sulla Relazione Medico-Paziente al Pronto Soccorso”” in IV Congresso NazionaleAIP Sezione di Psicologia Clinica – Riassunto delle Comunicazioni - IV Congresso Nazionale AIP Sezione di Psicologia Clinica, Bellaria – Rimini, 13-14 Settembre 2002.
- Piazza A Russo M.,.Picone L.,, “Nascere per non morire. Una Ricerca su Psicodinamice della Gravidanza, Immaginario del Parto ed Angoscia di Morte”-” in Atti del V Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute“Psicologia della Salute: Formazione e Interventi”, Firenze 18-19-20 ottobre 2002;
- Piazza A., Russo M.,., “Relazione di Cura, Relazione che Cura. Un Modello Psicodinamico di intervento per la Formazione Psicologica come Risorsa Strategica per l’Azienda Sanitaria”” in Atti del V Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute “Psicologia dellaSalute: Formazione e Interventi”, Firenze 18-19-20 ottobre 2002;
- Piazza A., Russo M., “I Rischi della Prevenzione: un modello di intervento e promozione dellla Salute nella Scuola” in Atti del V Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della
Salute “Psicologia della Salute: Formazione e Interventi”, Firenze 18-19-20 ottobre 2002;
- Piazza A., Favaloro R., Novembre M.R., Russo M., Tullio V., “I rischi della prevenzione: un modello di intervento e promozione della salute nella scuola” in Atti del V Congresso Nazionale Società Italiana diPsicologia della Salute “Psicologia della Salute: Formazione e Interventi”, Firenze 18-19-20 ottobre 2002;
- Piazza A., Favaloro R., Novembre M.R., Russo M., Tullio V., “Criteri di cittadinanza multiculturali e modelli di salute in una comunità plurietnica: una ricerca sugli Ivoriani in Italia” in Atti del V Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute “Psicologia della Salute: Formazione e Interventi”,Firenze 18-19-20 ottobre 2002;
- Piazza A., Favaloro R., Novembre M.R., Russo M., Tullio V., “Salute e soggettività infantile: una
ricerca sui processi di simbolizzazione dell’identità sociale attraverso l’esplorazione ludica della città” in Atti del V Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute “Psicologia della Salute: Formazione e Interventi”, Firenze 18-19-20 ottobre 2002;
- Piazza A., Russo M., “Atopon e soggettualità.Modelli, interventi e stereotipi nelle azioni di sviluppo del territorio eterotopico”” in Atti del Secondo Incontro Nazionale su “La Psicologia Ambientale in Italia”, Roma, 6-7 dicembre 2002.
- Piazza A., Tullio V., Ajello G., Giannì G., Prestifilippo C., Russo M., Sturniolo G., “A luci spente. La cittadinanza come esperienza di esclusione” in Atti del Secondo Incontro Nazionale su “La Psicologia Ambientale in Italia”, Roma, 6-7 dicembre 2002.
- Piazza A., Tullio V., Culotta R., Favaloro R., Novembre M.R., Russo M., Sturniolo G., “Dentro i vicoli. Il territorio come un gioco sognato dall’infanzia” in Atti del Secondo Incontro Nazionale su “La Psicologia Ambientale in Italia”, Roma, 6-7 dicembre 2002.
Russo M., “Il Complesso Scenario della Formazione Professionale” in “Lavori in Corso”, ed. Unindustria Treviso, marzo-aprile 2003
Russo M., “Il volontariato civile come nuova prospettiva lavorativa” in “Lavori in Corso”, ed. Unindustria Treviso dicembre 2003
Schimmenti A., G. Ajello, Russo M., Sturniolo g., Zaoner L., Scenari dal futuro: immaginario e rappresentazioni dell’utilizzo delle nuove tecnologie nel contesto scolsastico, in Atti del Congresso Contesto, cultura, intervento. Quale Psicoloia per la scuola del futuro, Lecce, 20-22 giugno 2003
- Piazza A., Tullio V., Culotta R., Oteri S., Schimmenti A. Russo M, “Storie che nutrono. Il focus/group psicodinamico come strumento di valutazione in psicologia clinica” ” in Atti del V Congressoo Nazionale AIP Sezione di PsicologiaClinica – Bari, 26 e 27 Settembre 2003
Russo M., Giannì G., Monforte M., Novembre M.R., Sturniolo G., “La scuola come nuovo paese dei balocchi. Una lettura psicodinamica del rischio di dispersione scolastica” ” in Atti del V Congresso Nazionale AIP Sezione di Psicologia Clinica – Bari, 26 e 27 Settembre 2003
Russo M., - Prestifilippo C., Longo B., Tutone A., “Dalla multimedialità alla multidisciplinarità: il linguaggio tecnicistico nel lavoro d’equipe” in Atti del I Congresso Nazionale“Medicina e Psicologia tra Terapia e Manipolazione. Informazione e disinformazione sulla salute nelloscenario della intermultimedialità”, Roma, 1-2-3 Ottobre 2003.
- Longo B – Ajello G.,, Giannì G., Monforte M., Russo M ““I siti web per la salute: quando la rete è una trappola in Atti del I Congresso Nazionale “Medicina e Psicologia tra Terapia e Manipolazione. Informazione e disinformazione sulla salute nello scenario dellaintermultimedialità”, Roma, 1-2-3 Ottobre 2003.
- Piazza A., Russo M., Conflitti tecnicomediati. Una ricerca clinica sull’allarme cyberwaar in internet, in Atti del VI Congresso Nazionale AIP Sezione di Psicologia Sociale – Sciacca , 22 e 24 Settembre 2004
- Piazza A., Tullio V., Russo M., “Prendersi cura del malato di Alzheimer: rappresentazioni e vissuti degli operatori” in Atti del VII Congresso Nazionale AIP- Sezione di Psicologia Clinica, Cagliari, 23-24 settembre 2005.
- Tullio V., Russo M., Prestifilippo C., “Padri in attesa. Una ricerca sulla psicodinamica paterna” in Atti del VII Congresso Nazionale AIP- Sezione di Psicologia Clinica, Cagliari, 23-24 settembre 2005;
- A. Piazza, G. Ajello, C. Prestifilippo, M. Russo, V. Visani Lo specchio nel Tempo: Vissuti degli Adolescenti sul Corpo dei Coetanei con Handicap e degli Anziani in Atti Convegno C.U.R.A.: Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2005, Milano, 1-3 Dicembre 2005.
- A. Piazza, S. Oteri, A. Schimmenti, M. Russo, G. Giannì La Comunicazione nella Malattia Cronic aVite di Cristallo: l’Identità Psicocorporea in Soggetti Emofilici in Atti Convegno C.U.R.A.: Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2005, Milano, 1-3 Dicembre 2005.
- Piazza A., Tullio V., Algeri D., Russo M., Zaoner L., “Prevenzione e/è Comunicazione? Uno studio sulconsumo tabagico tra gli adolescenti” in Atti Convegno C.U.R.A.: Conferenza sulla Comunicazione per laSalute 2005, Milano, 1-3 Dicembre 2005.
- Piazza A. Piazza, A. Schimmenti, G. Giannì, S. Oteri, M. Russo il trapianto di midollo osseo tra morte e rinascita dell’identità: un contributo di ricerca” in Atti Convegno C.U.R.A.: Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2005, Milano, 1-3 Dicembre 2005.
- A. Piazza, M. Russo, C. Prestifilippo, A. Schimmenti, L. Zaoner Il Linguaggio Tecnicistico e la Comunicazione per la Salute in Atti Convegno C.U.R.A.: Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2005, Milano, 1-3 Dicembre 2005.
A. Piazza^, A. Schimmenti*, G. Ajello^, C. Prestifilippo^, M. Russo^ le rappresentazioni dell’abuso: una ricerca con gli operatori del progetto “campo infanzia serena”” in Atti Convegno C.U.R.A.: Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2005, Milano, 1-3 Dicembre 2005.
Maria Russo “Sapersi Amare: L’arte di aver cura di se”- Agrigento maggio 2006
G. Ajello, G. Giannì, M. Russo, Di fronte all’emergenza. Uno studio sui volontari della croce rossa, in Atti Congresso Nazionale della Sezione di psicologia Clinica Dinamica. Rovereto 15-17 settembre 2006
G. Giannì, G. Ajello, , M. Russo, “Sordi” a scuola: tra costruzione dell’identità e cristallizzazione dello svantaggio, in Atti Congresso Nazionale della Sezione di psicologia Clinica Dinamica. Rovereto 15-17 settembre 2006
Russo M., Il lavoro con le famiglie. Per un’ “educazione alla personalità” psicodinamicamente orientata, in Atti della Settimana della salute, Piazza Armerina 23-28 ottobre 2006
Maria Russo- “ Per una Babele comuinicativa: il linguaggio tecnicistico nei luoghi di cura”, Giornata di studio “Gli operatori della salute e i processi comunicativi”, Agrigento 28 giugno 2007
A. Piazza., G. Ajello, G. Giannì, M. Russo I disegni del disagio psichico. L’esperienza di arteterapia di un soggetto psicotico, C.U.R.A. Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2007Università degli Studi di Milano, Milano, 8-10 novembre 2007
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella, L’intervento psicologico nell’emergenza: il caso di Veronica, C.U.R.A. Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2007, Università degli Studi di Milano, Milano, 8-10 novembre 2007
A. Piazza, M. Russo, S. Oteri, G. Vella, Le dimensioni affettive nella comunicazione della “cattiva notizia” , , C.U.R.A. Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2007, Università degli Studi di Milano, Milano, 8-10 novembre 2007
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella, Artiterapie e rieducazione del paziente psichiatrico, , C.U.R.A. Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2007 , Università degli Studi di Milano, Milano, 8-10 novembre 2007
A. Piazza, V. Tullio, S. Oteri, M. Russo, Resilienza e Processo di Cura, , C.U.R.A. Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2007, Università degli Studi di Milano, Milano, 8-10 novembre 2007
Piazza, V. Tullio, S. Oteri, M.Russo M., saggio La funzione di Resilienza nella Cura, in Sulla cura relazionale, Collana Satya, Ed. Canossi, Cairano 2007
A Piazza, M.Russo M., V. Tullio, Vella G., saggio Il paziente Psichiatrico in arteterapia, in Sulla cura relazionale, Collana Satya, Ed. Canossi, Cairano 2007
A Piazza, M.Russo M., Oteri S.,, Vella G., saggio Comunicare “cattive notizie ” in oncologia, in Sulla cura relazionale, Collana Satya, Ed. Canossi, Cairano 2007
A Piazza, M.Russo M., V. Tullio, Vella G., saggio Cura psicologica in emergenza, in Sulla cura relazionale, Collana Satya, Ed. Canossi, Cairano 2007
A Piazza, Ajello g., Gianni G.,M.Russo M., G., saggio Arteterapia in psicosi attraverso il disegno, in Sulla cura relazionale, Collana Satya, Ed. Canossi, Cairano 2007
Russo M., Per una Babele Comunicativa: il linguaggio tecnicistico nei luoghi di cura, in Atti della Giornata di Studio Gli operatori della salute e i processi comunicativi, Agrigento 28 giugno 2007
Ajello G., Giannì G., Russo M. Schimmenti A.,, Tra immaginario e contatto. Sessualità e adolescenza, In atti del VII Congresso Nazionale di psicologia della salute Promuovere Benessere con persone gruppi Comunità,
Ajello G., Giannì G., Russo M. Prestifilippo C., Corpi liminari: handicap e senilità nelle rappresentazioni degli adolescenti, In atti del VII Congresso Nazionale di psicologia della salute Promuovere Benessere con persone gruppi Comunità
Ajello G., Giannì G., Russo M. Prestifilippo C.,.,, Colori che nutrono sorrisi che curano: l’intervento clownterapeutico in comico-terapia, In atti del VII Congresso Nazionale di psicologia della salute Promuovere Benessere con persone gruppi Comunità
Ajello G., Giannì G., Russo M., , CURA E CREATIVITÀ: QUANDO LO PSICOLOGO È ARTETERAPEUTA. , X Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica Dinamica, Padova, 12-14 settembr 2008
Ajello G., Giannì G., Russo M., LINEE, FORME E COLORI DEL DISAGIO PSICHICO, , X Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica Dinamica, Padova, 12-14 settembr 2008-

null
C.U.R.A.
Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2007
Università degli Studi di Milano
Milano, 8-10 novembre 2007
Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2007
Università degli Studi di Milano
Milano, 8-10 novembre 2007
Elenco dei Titoli dei Contributi proposti:
A. Piazza, V. Tullio, S. Oteri, M. Russo
Titolo: Resilienza e Processo di Cura
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella
Titolo: Artiterapie e rieducazione del paziente psichiatrico
A. Piazza, M. Russo, S. Oteri, G. Vella
Titolo: Le dimensioni affettive nella comunicazione della “cattiva notizia”
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella
Titolo: L’intervento psicologico nell’emergenza: il caso di Veronica
A. Piazza., G. Ajello, G. Giannì, M. Russo
Titolo: I disegni del disagio psichico. L’esperienza di arteterapia di un soggetto psicotico.
A. Piazza, V. Tullio, S. Oteri, M. Russo
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Palermo
Titolo: Resilienza e Processo di Cura
Il costrutto di Resilienza (resiliency) viene definito nella letteratura medico-psicologica come la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici (malattie, traumi, eventi stressanti, catastrofi etc.), di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. La resilienza può essere considerata una risposta complementare alla presa in carico e cura della vulnerabilità di un soggetto permettendone una differente modulazione (Anthony, 2004); comprendere le implicanze di tale costrutto nel processo di cura può consentire all’operatore di aiutare il paziente nel difficile quanto indispensabile processo di trasformazione di un evento critico e destabilizzante in motore di ricerca personale. Parafrasando Scala (1998), possiamo affermare che “ogni percorso di presa in carico è un cammino condotto da persone (gli operatori) con persone (i pazienti e i loro familiari) verso una meta comune (la cura)” e affinché ciò accada è indispensabile che si costruisca una relazione di fiducia tra l’operatore e l’utente.
In tale prospettiva epistemologica, assumono particolare rilievo sia le caratteristiche fondanti la relazione e la comunicazione operatore/paziente. Se è vero che la resilienza è una caratteristica/capacità altamente soggettiva, è altrettanto vero che esistono possibilità di sviluppare questa risorsa personale e sociale presente in stato di latenza in ogni individuo; potenziare questa forza interiore, tanto negli operatori quanto nei pazienti può significare elevare il livello generale di salute e qualità della vita implementando nei soggetti la capacità di reagire ai colpi della vita, di risollevarsi e di ricostruirsi.
Bibliografia
Anthony W. A., The decade of the Person, Center for Psychiatric Rehabilitation, Behavioural Healtyhcare Tomorrow, Boston, 2004.
Piazza A., Tullio V., “Morte come temenos: sul prendersi cura del fine/della fine”, in La CURA, Atti della Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2005, n.2, 2006.
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Palermo
Titolo: Artiterapie e rieducazione del paziente psichiatrico
L’uso sempre più incisivo delle artiterapie in ambito terapeutico sembra sottolineare l’esigenza, da parte della psichiatria, di rintracciare visioni interventive innovative e più funzionali per far fronte alla patologia, nella prospettiva di attivare ulteriori occasioni e nuovi luoghi in grado di meglio gestire quello che la Carozza definisce “una compagna di vita scomoda e inquietante” (Carozza, 2003), ovvero la sofferenza mentale.
Il presente lavoro scaturisce dal confronto tra diverse realtà comunitarie riabilitative, utilizzati nella patologia psichiatrica, presenti nel territorio siciliano, all’interno delle quali viene praticata l’applicazione delle artiterapie in ambito riabilitativo. In tali realtà territoriali l’arte sembra assumere delle caratteristiche del tutto peculiari, divenendo una modalità privilegiata per esplorare la realtà, per comunicare vissuti ed esperienze che, altrimenti, potrebbero rimanere segreti. Tuttavia le differenti esperienze messe a confronto, spingono a riflettere su aspetto inquietante della creatività, che vede impegnata la comunità scientifica da diversi decenni. La tendenza attuale, infatti, sembra spingere impositivamente verso la creatività dei pazienti. Un così peculiare modello culturale può potenzialmente schiacciare e/o esaltare il paziente psichiatrico che, pressato dalla richiesta di espressione di una presunta geniale creatività, può rintracciare nell’atto “creativo” il mezzo per ottenere le attenzioni dei riabilitatori. Bisognerebbe invitare i riabilitatori, parafrasando Ancona (Ancona, 2004), ad una riabilitazione che passi anche attraverso la tolleranza dell’insignificanza, poichè infodere il “furore creativo” nel paziente rischia di diventare la reificazione di un atto onnipotente del riabilitatore, una proiezione delle sue parti narcisistiche. Ogni percorso riabilitativo presuppone un incessante ascolto e revisione psicodinamica dei vissuti dei soggetti coinvolti (operatori e pazienti) del gioco di proiezioni reciproco. Le riflessioni conclusive ci spingono ad ipotizzare che un gruppo che vanti pretese riabilitative dovrebbe essere concepito come uno spazio di condivisione, esente da massificanti pretese creative, un tassello del percorso riabilitativo dei pazienti in cui si incontrano istanze psicologiche collettive ed individuali, dove poter sperimentare nuove consapevolezze dischiudendo nuove possibilità esistenziali.
Bibliografia
Ancona P., “Introduzione”, in Appunti di viaggio, 1 (2004), 5.
Ba G., “L’arte terapia come intervento riabilitativo nel trattamento del paziente psichiatrico”, in Lorenzetti L. M. (a cura di), La dimensione estetica dell’esperienza, Franco Angeli, Milano, 1995.
Carozza P., La riabilitazione psichiatrica nei centri diurni, Franco Angeli, Milano, 2003.
A. Piazza, M. Russo, S. Oteri, G. Vella
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Palermo
Titolo: Le dimensioni affettive nella comunicazione della “cattiva notizia”
Il riconoscimento della capacità comunicativa degli operatori della salute con il malato oncologico come un “momento strategico” dell’assistenza, sembra ormai rappresentare un assunto condiviso dalla comunità scientifica.
La presente relazione scaturisce dalla riflessione trasversale su una serie di interventi ospedalieri che segnala la necessaria promozione di un agire medico più affettivizzato, in grado di cogliere ed anticipare vissuti e bisogni psicologici, accostandosi al paziente attraverso un canale empatico capace di favorire quell’alleanza di lavoro necessaria per stimolare il processo di autoguarigione. L’apertura a fornire esaurienti informazioni e spiegazioni al paziente costituirebbe infatti un fattore terapeutico, poiché rimanda al paziente la sensazione di una presenza reale e di un autentico intento terapeutico, in cui la disponibilità emozionale appare fondamentale. Ci sembra di poter affermare come una sensibilità psicologica nella gestione della cattiva notizia oncologica risulti ancora carente, mostrandoci operatori della salute spesso difensivamente sordi al bisogno del paziente di essere sostenuto nel travagliato processo di elaborazione della diagnosi e dei vissuti connessi alla malattia, per riuscire a raggiungere un più funzionale adattamento alla condizione attuale e alle terapie future. Il modello d’intervento privilegiato partiva dall’ipotesi che l’attenzione alle dimensioni emotivo–affettive, la capacità di risvegliare le <<parti affettive fauste che possano contrastare non solo con il cancro ma anche le potenze affettive infauste da esso generate>> (Burrone A., Fornari F., 1999), possano facilitare il processo di cura, e fare in modo che i pazienti possano attingere a <<quei dispositivi innati che ognuno ha dentro di sé che lo spingono a reagire al male col bene. L’incidenza del male stesso può attivare la ricerca del bene e se questa ricerca sarà aiutata da un’adeguata azione psicoprofilattica potrà condurre al miracolo di far sì che la gioia alimenti di energie le cellule>> .
Bibliografia
Burrone A., Fornari F., La terapia degli affetti, Bologna, 1999
Chiozza L.A., (1981), Psicoanalisi e cancro. Borla, Roma.
Crocetti G. (a cura di), (1992), Ascolto terapeutico e comunicazione in oncologia. Borla, Roma.
Sontag S., (1979), “Malattia come metafora” Il cancro e la sua mitologia, Einaudi Editore
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Palermo
Titolo: L’intervento psicologico nell’emergenza: il caso di Veronica
Oggetto della presente relazione sarà la resocontazione di un intervento in psicologia dell’emergenza attraverso la narrazione del caso di Veronica, arrivata alla mia attenzione in seguito ad un incidente stradale che, da vittima primaria di un trauma o vittima che ha subito un danno diretto (Dominici R., 2006), è stata costretta a vivere simultaneamente, o forse prevalentemente, il ruolo di vittima secondaria di un danno indiretto (Dominici R., 2006), avendo contemporaneamente assistito alla morte del fidanzato, alla guida della motocicletta al momento dell’incidente stradale. L’intervento da psicologia dell’emergenza si è gradualmente evoluto in un percorso di sostegno del processo di elaborazione del lutto, guidati dall’ipotesi terapeutica di un processo di elaborazione del lutto concepito come percorso creativo in grado di costellare e dischiudere, una volta superati i penosi momenti paralizzanti della perdita, nuove possibilità trasformative e di emancipazione della personalità.
L’evoluzione del caso clinico, dispiegatosi lungo un complesso e travagliato susseguirsi di fasi evolutive, di piccole pause interne e di fisiologici movimenti regressivi sembra avvalorare questa ipotesi di lavoro. Il nostro primo incontro, è avvenuto nel giorno successivo all’incidente, in ospedale. L’intervento precoce (consistente nell’offerta immediata di un sostegno psicologico in fase acuta), in un siffatto contesto di emergenza, legato alla perdita improvvisa del proprio compagno, costituì un fattore terapeutico e di protezione che favorì un fisiologico decorso del processo di elaborazione del lutto ed una prevenzione della cronicizzazione del Disturbo Post Traumatico da Stress.
L’ipotesi terapeutica è stata confermata: l’elaborazione fisiologica del lutto sembra davvero aver gettato le basi per una effettiva trasformazione della paziente testimoniando la possibilità di una crescita post traumatica
Bibliografia
AA.VV., “La perdita: lutti e trasformazioni”, Rivista di Psicologia Analitica, n. 17, 69/2004
Dominici R., Il danno psichico ed esistenziale, Giuffrè, Milano, 2006
Kast V., (1982), L'esperienza del distacco - Lutto, perdita, abbandono come occasione di trasformazione e crescita, Red, Milano, 2005.
A. Piazza., G. Ajello, G. Giannì, M. Russo
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Palermo
Titolo: I disegni del disagio psichico. L’esperienza di arteterapia di un soggetto psicotico.
Tale lavoro si propone di esplorare l’ambito delle artiterapie e in particolare come queste possano essere impiegate con soggetti psicotici che presentano delle difficoltà a livello della comunicazione verbale. Poiché «l’arteterapia si configura come un sistema flessibile e pragmatico, che individua i propri elementi costitutivi nel delicato equilibrio tra procedure, tecniche e libertà espressiva, tra la cornice dello scenario, il setting artistico e le dinamiche relazionali sollecitate dal processo creativo» (Bedoni G., Tosatti B., 2000), è possibile descrivere l’arteterapia come uno strumento che può favorire lo sviluppo personale attraverso forme alternative di comunicazione. Vari studi (Ortoleva R., Testa F., 2003) hanno messo in evidenza come l’arteterapia ricorra ad un codice linguistico diverso rispetto alla parola, e pertanto “linee, forme e colori possono effettivamente rappresentare un punto di fuga che interrompe il circuito vizioso del sintomo: incoraggiando una positiva immagine di sé, e fornire un’esperienza che apre nuove prospettive anche sul piano di un’elaborazione verbale” (Trivelli C. P., Taverna A., 2000). La finalità di tale studio è quella di capire, da un punto di vista psicodinamico, come l’arte terapia possa essere, per i pazienti in cura presso le C.T.A., un esercizio utile a stimolare la comunicazione di vissuti ed esperienze che altrimenti potrebbero rimanere inespressi. Pertanto abbiamo incontrato un paziente di una C.T.A. siciliana, che ha partecipato al laboratorio artistico svoltosi nella C.T.A. stessa. Sulla base delle riflessioni emerse durante l’incontro con M., è stato possibile evidenziare come attraverso il disegno, all’interno del percorso arteterapeutico, il soggetto abbia avuto la possibilità di prendere coscienza di alcuni sentimenti. A proposito dell’espressione artistica, il paziente dice: “è un momento di libera espressione, di comunicazione interiore, che mi permette di esprimere il mio mondo interno, il mio stato d’animo. Il disegno è un momento di libertà interiore”.
Bibliografia
Bedoni G., Tosatti B., (a cura di), Arte e psichiatria. Uno sguardo sottile, Mazzotta, Milano, 2000
Ortoleva R., Testa F., (a cura di), Psicosi e Creatività. Le storie che curano. La biblioteca di Vivarium, Milano, 2003.
Trivelli C. P., Taverna A., (a cura di), Arti Terapie. I fondamenti, Tirrenia Stampatori, Torino, 2000.

null
La scuola come Nuovo paese dei balocchi. una lettura psicodinamica del rischio di dispersione scolastica.
-M. Russo, G. Giannì, M. Monforte, M. R. Novembre, G. Sturniolo
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Palermo
Introduzione
Questo lavoro fa parte di un progetto più ampio sulla "Prevenzione
della Dispersione Scolastica e degli Insuccessi Formativi"
realizzata all'interno di un Istituto Comprensivo dell'entroterra
siciliano. La comunità scientifica, con la locuzione "Dispersione
Scolaslica", intende riferirsi all'insieme di manifestazioni che
determinano interruzioni o rallentamenti dell'iter formativo. Si è
soliti distinguere la dispersione da "evasione" e dalla dispersione
da "fuga"; nel primo caso si fa riferimento alle mancate iscrizioni,
nel secondo agli abbandoni scolastici veri e propri. La finalità del
nostro lavoro è stata quella di esplorare le dinamiche, che
sottendono il disagio scolastico e il processo di adattamento
realizzato.
Metodo
Gli obiettivi della ricerca hanno riguardato: l'esplorazione delle
rappresentazioni e dei vissuti degli alunni e dei docenti relative a
fenomeno della dispersione scolastica e relativi allo "stare in
classe", e le dinamiche insite nella relazione alunno/insegnante. A
partire da una visione complessa della dispersione scolastica, in
cui confluiscono fattori sociali, familiari, economici, relazionali e
culturali, l'ipotesi che ha guidato il nostro lavoro è che i modelli di
"salute", attivamente presenti nelle azioni e nelle dinamiche della
scuola, condizionano la manifestazione di fenomenologie
specifiche, quali la dispersione scolastica e gli insuccessi formativi"
La Rilevazione dei Dati è stata compiuta con un ampio numero di
soggetti: hanno parlecipato i 12 docenti ed i 300 alunni dell'Istituto
Comprensivo Siciliano. Gli strumenti usati sono stati Colloqui,
"Secret Box" e Focus/Group. L'elaborazione dei Dati è stata
qualitativa, mediante griglie psicodinamiche, e quantitativa,
mediante l'uso di indici di statistica descrittiva.
Risultati
Dall'analisi dei dati del Focus-Group realizzato con un gruppo-
campione di nove studenti della Scuola Media, emerge una
notevole difficoltà da parte della scolaresca a "stare " a scuola.
L'immagine che i ragazzi ci offrono, è quella di una scuola "che
offre poco spazio per il gioco che pensa troppo alla teoria e poco
alla pratica". Inquietante la rappresentazione dei docenti, offerta
dagli alunni, vissuti come professionisti espulsivi e severi. Un altro
dato significativo, emerso come problema anche nel Focus-Group
con gli insegnanti, è relativo al dilemma della "bocciatura", in seno
al quale si dispiegano due fenomeni: da un lato un'indiretta
manifestazione d'episodi di "bullismo" attuato dagli alunni ripetenti,
dall'altro, una "fuga" dalla scuola dei soggetti bocciati, a causa
della derisione dà compagni più piccoli. Dall'analisi dei dati del
Focus-Group realizzato con un gruppo campione di nove studenti
della Scuola Elementare, si configura il profllo di una scolaresca
collaborativa ed attenta agli eventi che hanno dominato lo scenario
nazionale ed internazionale (cadute delle torri gemelle, terremoti,
ecc.), mostrando una sensibilità elevata verso gli aspetti legati alla
sicurezza dei bambini in istituti scolastici con caratteristiche
strutturali non sempre rassicuranti. Secondo i bambini per stare
bene a scuola si dovrebbe "disegnare, scherzare e divertirsi di
più". Infine, in un'attivazione, la scuola è simbolizzata come la
favola di pinocchio, con alunni ambivalenti nei confronti della
scuola, con presidi antropofagi, ma senza il "vissero felici e
contenti". Alla numerosa adesione all'iniziativa dei "secret box" da
parte degli alunni, non è corrisposta un'altrettanta, elevata
adesione da parte del corpo docente, soprattutto di quello operante
nella scuola media. La maggior parte dei bambini dichiara di non
trovarsi bene a scuola, dato significativo se correlato con l'illusoria "assenza di dispersione scolastica, o di rischio di dispersione", sostenuta dal corpo docente. Accanto all'immagine di alunni autopercepiti fondamentalmente "buoni, anche se troppo vivaci", emerge l'immagine di insegnanti "bizzarri", come riferiscono i bambini, che, in altre parole, a volte sono comprensivi, ma troppe
volte si "spazientiscono" per l'esuberanza degli alunni. Gli
insegnanti lamentano, con la nuova scuola dell'Autonomia
un'incapacità diffusa ad utilizzare in maniera ottimale e funzionale
la dimensione temporale, una non efficace gestione dei fondi a
disposizione, uno scarto a volte incolmabile tra l'avvento delle
nuove tecnologie e l'arretratezza tecnologica in cui versa la scuola.
Conclusioni
Le riflessioni che hanno fatto seguito al lavoro svolto hanno
consentito di individuare, tra le Ricadute Operative, la specificità
del Modello di Formazione gruppale fatto con i docenti. Da
un'iniziale reticenza e posizione difensiva, affrontando numerose
tematiche quali la bocciatura contestuale, il ruolo della famiglia
sull'educazione dei figli, l'elaborazione del lutto legato al passaggio
da un ordine di scuola ad un altro, ai pregiudizi ed agli stati
d'animo che influenzano la relazione insegnante/alunno, all'identità
di ruolo tale gruppo ha sperimentato un processo di
autoconsapevolezza delle dinamiche orizzontali e verticali esperite
nel contesto di riferimento, maturando una consapevole
committenza interna.

null
DENTRO I VICOLI IL TERRITORIO COME UN GIOCO SOGNATO DALL'INFANZIA
-
Antida Piazza, Rita Culotta, Rosanna Favaloro, Maria Rosalia Novembre, Maria Russo, Giuseppe Sturniolo, Valeria Tullio.
Uníversità degli Studi di Pctlermo. Dipartimento di Psicologia.
L'interesse per la relazione uomo-ambiente ha sicuramente coinvolto i piu diversi ambiti di ricerca. L'uomo. "attore e spettatore" (Tuni E., 1998) dell'ambiente, ha da sempre istintivamente conferito identità agli spazi, ha dato significati a tutto ciò che lo circonda, ed in questo "atto" di significazione ha osservato i luoghi, si è rispecchiato in essi, ed in essi ha conosciuto/riconosciuto se stesso. Come avviene con il conffonto con l'altro, che ci attraversa e ci arricchisce e contribuisce alla formazione dell'identità e delle matrici soggettive, così anche l'ambiente, con i suoi "spazi" ed i suoi "muri", sviluppa, limita o comunque partecipa al processo di riconoscimento della propria identità. All'intemo di questa cornice si colloca questo contributo di ricerca, compiuto nell'ambito di un progetto C.N.R., che si è proposto di analizzare il Modello di Cittadinanza e Soggettualità dell'Infanzia orientante l'ideazione e la realizzazione di Azioni di Sviluppo Sociotemtoriale della
città di Palermo destinate a bambini e preadolescenti, attraverso una lettura psicodinamica delle
rappresentazioni simboliche dell'ambiente ed in particolare dei "luoghi urbani". La nostra ipotesi di lavoro è che i modelli culturali, le rappresentazioni sociali, o più precisamente, la cultura "adultocentrica" a partire dalla quale vengono costruite offerte di visite territoriali destinate all'infanzia sia incapace di tener conto dell'immaginario inflantile, rendendo di fatto dissonanti i modi con cui gli operatori del settore del turismo propongono le esperienze ludiche ai visitatori bambini e preadolescenti, e l'immaginario che questi ultimi hanno rispetto alla scoperta della città, la cui valenza simbolica risiede nella possibilità di esprimere la propria cittadinanza. Attraverso l'esplorazione delle rappresentazioni e dei vissuti di bambini e preadolescenti coinvolti in attività di scoperta socioculturale della città di Palermo e di offerta turistica per coetanei, si è cercato di
incontrare il mondo interno dei bambini ed il loro sentirsi Soggetti di Cittadinanza, di comprendere quaìe modello di Cittadinanza Soggettuale fonda le forme di esperienza turistica (culturale, affettiva, istituzionale) che vengono considerate dal mondo degli adulti coerenti con l'immaginario sull'infanzia ed, infine, si è cercato di esplorare i valori latenti inerenti al tema dell'alterità ed alle aspettative espresse con i codici psicodinamici in essi implici riguardo alla relazione col turista bambino. L'utilizzo, da parte delle istituzioni territoriali, di parametri di cittadinanza socioculturale scotomizzanti la soggettualità infantile, lo scarto paradossale tra l'autoconsapevolezza ed originalità delle idee di valorizzazione dell'esperienza ludica, proposte dagli stessi bambini come elemento strategico della Cittadinanza Soggettuale Infantile e le iniziative attuate per loro dal
mondo degli operatori del settore, sono, in breve, alcuni dei risultati emersi dal nostro lavoro di ricerca cui si accompagna, quale ricaduta operativa, il tentativo di una traduzione dell' immaginano di un ottimale Fruizione lnfantile del Territorio in Strategie ed Azioni Sociali più adeguate.
Punti Chiave - La ricerca ha incontrato il mondo interno dell'infanzia ed il suo sentirsi Soggetto di
Cittadinanza Ambientale attraverso l'esplorazione delle rappresentazioni e dei vissuti di bambini e
preadolescenti coinvolti in attività di scoperta socioculturale della città e di offerta turistica per coetanei; ha valutato quale modello di Cittadinanza SoggettuaÌe fonda le forme di esperienza territoriale che vengono considerate dal mondo degli adulti, ed in particolare da quelli di essi che si occupano direttamente della formazione scolastica dei bambini, coerenti con l'immaginario
sull' infanzia; e ha esplorato i valori latenti inerenti ai codici psicodinamici in essi impliciti riguardo alla relazione col visitatore bambino. Per raggiungere tali obiettivi, dopo un'indagine preliminare condotta con 500 studenti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni, volta ad identificare i luoghi e monumenti della città preferiti dai bambini. le cui foto sono poi state utilizzate
durante la ricerca, abbiamo ulilizzato:
a) qustestionario individuale e focus-groups con attivazioni psicodrammatiche, volti ad esplorare il modo con cui i bambini ed i preadolescenti percepiscono la città e la cultura di cui è veicolo, rivolti a 1000 studenti di Scuola Media, di età compresa tra i 10 ed i 14 anni, equidistribuiti per sesso e frequentanti istituti siti in quartieri rispecchianti tre condizioni socio-culturali diverse della città (contesto ad elevate condizioni socio-economiche, contesto economicamente svantaggiato, contesto urbanisticamente periferico);
b) focus-groups con attivazioni psicodrammatiche, con l0 gruppi composti ciascuno da 12 studenti della Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, facenti parte di un'unità di lavoro impegnata in attività di ricerca e di progettazione strategica sui criteri di fruibilità dei beni artistici;
c) intervisîe con testimoni privilegiati, cioé operatori del settore turistico, referenti istituzionali (assessori, dirigenti etc.) ed insegnanti, scelti perché attivamente impegnati in iniziative inerenti al tema della ricerca. Non vi sono discrepanze rilevanti quantitativamente tra i luoghi scelti dagli studenti dei tre plessi scolastici, ma differente è invece il "come" queste scelte sono state fatte: coloro che vivono nella zona centrale esprimono una scelta di luoghi conosciuti direttamente, ma per gli altri ragazzi la distanza 'fisica' (nel caso degli studenti della scuola urbanisticamente periferica) o la distanza 'affettiva' dalla città (per i ragazzi frequentanti il plesso scolastico del quartiere caratterizzato da marginalità economica e disagio sociale) si traduce in una conseguente
distanza psicologica anche dal patrimonio culturale della città e dalla "storia" della propria identità. Si sottolinea la necessità di legare l'esperienza territoriale al gioco; prende voce il bisogno di una conoscenza dell'ambiente che non sia solo "intellettiva e visiva" ma anche "corporea", e non manca, perfino nei piccolissimi, la capacità dei bambini di "empatizzare" con i monumenti <<sofferenti perché deturpati>>; con una forte identificazione (ed, a tratti, adesione) cognitiva ed emotiva nei confronti della loro città, sia sotto il profilo storico/culturale sia riguardo quegli avvenimenti che con alterne vicende l'hanno segnata,desiderio,/bisogno che è stato espresso nel racconto di un'ipotetica passeggiata alla scoperta del territorío con una compagnia ideale a loro scelta, spesso identificata in un coetaneo, o in un personaggio fantastico ma pur sempre capace di guardare il mondo con i loro stessi occhi,come ad esempio ET.
- Operatori ed Educatori simbolizzano il Turismo lnfantile entro due direttrici opposte ma entrambe
adultocentriche,secondo cui le visite artistico/culturali devono essere gestite dagli adulti come spazio educativo, con l'aspettativa che il bambino rinunci al proprio mondo immaginario ed alla propria espressività attraverso il gioco per 'assorbire passivamente' il codice culturale degli adulti; il divertimento dei bambini deve "essere relegato" in spazi ludici non sincronici alla fluizione artistico/culturale del territorio, con la presenza di personale adulto capace di agire come animatore ed al quale lasciarli in custodia durante lo svolgimento delle visite da compiersi solo tra adulti; nel loro Immaginario di un'ottimale Fruizione lnfantile del Territorio, gli Adulti sembrano sconoscere il processo di comprensione/intervento che è costituito "dall'analisi della
domanda" che consiste nella sospensione di quel processo di pre-determinazione normativizzante e rassicurante della richiesta e nel processo di ri-significazione delle simbolizzazioni fondanti la relazione con l,Altro. Al contrario, la promozione della soggettività infantile attraverso l'esplorazione della simbolizzazione del temitorio come esperienza ludica ha trovato piena realizzazione nelle proposte concrete dei bambini: guide bambine per visitatori bambini, che raccontino la storia del luogo da visitare attraverso la narrazione delle avventure della vita di loro coetanei vissuti lì nel periodo fondativo; la presenza di uno spazio per la creatività infantile all'interno dei siti monumentali, dove i bambini possano disegnare ciò che stanno scoprendo o farne una ricostruzione "a puzzle", magari col computer; la realizzazione di fasce orarie o aree nelle quali i siti artistici siano riservati a giochi, come la "caccia al tesoro" oppure il "nascondino", tematizzati sul contenuto del sito stesso; la presenza di personaggi in costume che mettano in scena una breve storia ambientata dentro il monumento, con 'oggetti parlanti' e guide/pagliacci che raccontino in modo spassoso e musicato le informazioni più importanti; la presenza di una stanza che, all'interno del monumento, lo riproduca con materiali adatti ad essere manipolati e smontati, ed esoneri dal divieto di toccare le opere d'arte che spesso viene loro rivolto; la possibilità di essere accompagnati da un 'cantastorie personale' che, durante la scoperta del luogo, immagini per loro di ambientare avventure in musica. Inoltre i viaggiatori bambini vorrebbero la condivisione dell'esperienza turistica con coetanei del posto che visitano, e la possibilità di 'giocare insieme',
nei posti artistici più belli per,scoprirli attraverso la propria creatività.

null
Storie che nutrono ll focus group psicodinamico come strumento di di valutazione in psicologia clinica
-
A. Piazza, R. Favaloro, G. Aiello, M.R. Novembre, M. Russo
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Palermo
Introduzione
Oggetto di questo contributo è il resoconto di una Ricerca/Intervento sul tema della Valutazione in Psicologia Clinica; in particolare, la nostra ricerca ha avuto la Finalità di contribuire alla costruzione di un modello psicodinamico di "valutazione" delle dinamiche professionali, personali e istituzionali, che emergono in ogni intervento psicologico, attraverso l'uso della "narrazione psicodinamica gruppale", quale modalità privilegiata per attraversare le dimensioni individuali, gruppali ed organizzative.
Metodo
A partire dall'idea, condivisa all'interno della comunità scientifica, che la tessitura delle trame narrative costituisca un dispositivo collettivo particolarmente proficuo per l'individuazione delle
modalità relazionali e di lettura del reale degli individui,l'Obiettivo specifico che ci siamo proposti è stato l'esplorazione dell'efficacia di uno specifico dispositivo narrativo, il Focus/Group psicodinamico con tecniche psicodrammatiche, per la valutazione degli interventi psicologici. Si è formulata l'ipotesi che la specificità della modalità narrativa del Focus/Group possa favorire l'attivazione di una presa di consapevolezza circa le dinamiche agite da tutti gli attori coinvolti nel particolare contesto preso in esame. Per rilevare i dati si è avvalsi di diverse Organizzazioni: 10 Scuole Materne, 15 Elementari, 20 Medie inferiori e 20 Superiori,12 gruppi di studenti di Università, 8 gruppi di operatori di altrettanti Enti di Formazione Professionale, 12 gruppi di dipendenti di Aziende, 30 gruppi di operatori afferenti a Strutture Sanitarie, ed ha sempre coinvolto
campioni significativi di tutti i Soggetti afferenti alle strutture considerate. Si è utilizzato come strumento, il Focus/Group, che e stato strutturato in un colloquio di gruppo in profondità costituito da 6 fasi:
1)presentazione dello staff (composto da un conduttore, un facilitatore ed un osservatore silente), degli obiettivi del lavoro e dei partecipanti (da 9 a12 persone);
2)esplorazione del set valoriale dei partecipanti, rispetto alle risonanze personali di eventi collettivi tramite l'attivazione di discussione di gruppo circa gli eventi indicati come particolarmente significativi dai partecipanti nell'ambito di "parametri"(anni,luoghi geografici, ambiti disciplinari, target di referenzialità) esplicitamente definiti dal conduttore;
3)focalizzazione sulla tematica specifica di discussione anche mediante l'ausilio di stimoli piu o meno strutturati (montaggi di spezzoni video, cartelloni con foto-stimolo. etc.);
4) proposta di rappresentazione, mediante una narrazione condivisa e gruppale (fiaba, film, filastrocca, etc.) di una "storia" con personaggi che il gruppo senta rispondenti alla propria fantasia
sulla tematica considerata;
5) psicodramma basato su tale racconto, dove il conduttore talvolta interviene per sottolineare la dinamica emergente;
6) chiusura della sessione di lavoro, accompagnata da una breve ricapitolazione dei principali elementi informatvi emersi, in modo da raccogliere eventuali ulteriori associazioni dei partecipanti.
Risultati
Si sono elaborati i dati qualitativi, raccolti tramite apposite griglie interpretative, è stato possibile individuare, come risultati della nostra ricerca, alcuni criteri-chiave per rintracciare i codici emotivi e cognitivi peculiari del resoconto narrativo in contesti
individuali/gruppali/organizzativi, per leggere, analizzare, restituire il "senso" delle rappresentazioni sociali dei soggetti partecipanti narrate nelle sessioni di Focus/group. Attraverso l'utilizzo del Focus/group come strumento di resoconto/valutazione, la valutazione si propone come un processo ermeneutico capace di
tenere conto non solo dei sistemi cognitivi, affettivi, valoriali con cui ogni soggetto (singolo o plurale) costruisce e fa propria la "realtà",ma anche della dinamica psicorelazionale dei diversi contesti di riferimento.
Conclusioni
La ricaduta operativa del lavoro svolto risiede nella possibilità, offerta da questo strumento narrativo, di costruire Modelli Psicodinamici di Valutazione capaci di fare dialogare le differenti rappresentazioni psicoaffettive che emergono nei resoconti, attivare processi di simbolopoiesi, consentendo l'accrescimento conoscitivo delle dinamiche individuali ed organizzativo-istituzionali

null
ATOPON E SOGGETTUALITA'. MODELLI. INTERVENTI E STERIOTIPI NELLE AZIONI DI SVIUPPO DEL TERRITORIO ETEROTOPICO.
-
Antida Piazza, Adriano Schimmenti, Gabriele Ajello, Rita Culotta, Gabriella Giannì, Sergio Oteri.
Maria Russo.
Università degli Studi di Palermo. Dipartimento di Psícologia.
"Lei non è del Castello, lei non è del paese, lei non e nulla. Eppure anche lei è qualcosa, sventuratamente, è un forestiero, uno che è sempre di troppo e sempre fra i piedi, uno che vi procura un mucchio di grattacapi."
Franz Kafka, Il castello.
Le culture metropolitane della submodemità sembrano sempre maggiormente fagocitare le potenzialità individuali di autonome e creative esplorazioni dell'ambìente,le capacità di (ri)attraversare quel territorio, polìedrico e metamorfico, in grado di donare-restituire la soggettualità storica riconducendola oltre il rigido determinismo dell'autoreferenzialità, del "conformismo nella differenza", di una sostanziale "geografia delle esclusioni" che satura le simbolizzazioni stesse dello spazio (inteso sia cone dimensione "fisica" del reale che
come "luogo interiore" della continuità storica e dell'appadenenza comunìtaria).
In tale prospettiva, l'adesione culturale di massa ad una "politica dell'individualismo" ha progressivamente enfatizzato la trasfigurazione delle aree urbane, rendendole talvolta testimonianza in vivo di processi eterotopici di frammentazione e reificazione dell'arnbiente, moltiplicando quei "non luoghi dell'essere transitorio" (Augé M., 1992) inagevoli all'incontro con l'Altro, il "forestiero", lo "straniero". Così la relazione circolare tra soggettività e alterità vive l'impoverimento iconoclasta della sparizione di un "ambiente fisico e vissuto", sempre più spesso percepito e rappresentato come mero sfondo distante, opaco, deprivato della sua pregnanza
simbolica oltre che relazionale. Tali riflessioni, maturate attraverso ricerche/intervento su Cittadinanza e Partecipazjone da noi condotte nel territorio siciliano, suggeriscono la necessità di progetti di implementazione, sviluppo e rivalutazione dello spazio urbano che centrino la presenza del cittadino come principale polo referenziale e protagonista di un ambiente riscoperto nella sua funzione antropologica, evocativa ed emozionale. Sono dunque, a nostro parere, proprio i "luoghi di transito e/o di transizioni" a necessitare primariamente di progetti di valorizzazione e trasformazione ambientale che consentano agli abitanti un "esserci" nella/della città, superandone una concezione riduzionisticamente tecnocentrica, e pertanto alienante.
E quindi imprescindibile l'assunzione di un Modello Epistemico volto a farsi carico della viscerale scotomizzazione sociale della problematizzazione e del travaglio degli interventi di sviluppo della Pluricittadinanza, che rintraccia nei vertici paradigmatici del "riparare versus trasformare", "sostenere versus valorizzare" e "prendersi cura versus promuovere autorealizzazione e dunque autocommittenza" tre direttrici di sviluppo sociale profondamente differenti.
Perlanto attraverso il riconcepimento dell"'ambiente vissuto" riteniamo possibile una progressiva ed autentica riscoperta del territorio, della originaria relazione che lo congiunge ai suoi abitanti e della feconda, creativa identità che può offrire ai "forestieri".
Punti Chiave - La "normalizzazione" delle rappresentazioni collettive ed individuali delle aree urbane riflette la dilatazione verso l'eccesso delle dimensioni di tempo e spazio, che tende ad isterilire le significazioni ed i vissuti soggettivi dell'ambiente; né peraltro la metropoli arresta la propna espansione o attende la capacità soggettiva di dare senso ai "nuovi luoghi", generando così non-luoghi che riconducono agli spazi di transito, commercio e trasporto, nonché al rapporto che l'individuo instaura con questi: tali spazi si costituiscono spesso come "aree di attraversamento" né identitarie, né relazionali, né storiche, poiché in essi i soggetti non
esprimono e non riconoscono differenze ed individualità.
I nonluoghi, a ragione di tale disarmante omologazione, diventano spesso i contenitori silenti ma appariscenti della solitudine e della sofferenza di identità smarrite e marginali. Ciò appare presente anche nella storia di una delle figure che anno solcato il nostro percorso di ricerca: "la Suora Nera". Per incontrarla ci rechiamo alla stazione ferroviaria di Patti, lungo il percorso tra Palermo e Messina, e prendiamo posto in uno scompartimento.Qui sale sul treno una donna di mezza età, che a prima vista appare come una "homeless". Porta con sé un carrellino della spesa piuttosto
malconcio, ed al guinzaglio improvvisato (una corda) ha un cane di razza husky, dall'aspetto "malaticcio"; la donna è abbigliata con una gonna ed una casacca nera, ed un foulard, anch'esso nero, avvolge il suo capo con cura e ne nasconde interamente ed "ordinatamente" la chioma. A distanza i suoi denti appaiono perturbantemente di metallo ma, più da vicino, ci si accorge che la donna li ha ricoperti con carta stagnola, ripiegandola accuratamente in maniera tale da aderire fedelmente alla sua dentatura; la donna appare agitata, irrequieta, attraversa e riattraversa il vagone ferroviario senza posa; nel suo frenetico passeggiare si sofferma più volte sulle piattaforme di contatto dei vagoni, e dalla porta a vetri del treno si riesce a scorgere la sua figura
che intona singolari "litanie". Si tratta di canti quasi certamente improvvisati, che per melodia e contenuti ricordano quel1i che è possibile ascoltare nelle chiese; il sentimento che questi canti suscitano è simile ad un'angoscia ed un'ansia per un vissuto doloroso, quasi straziante; tra le parole maggiormente ricorrenti vi sono "..cuore di carne, erba di vita...", e tra un verso e l'altro la donna si ferma invocando il nome di Dio a "squarciagola", rivolgendo più volte la domanda "perché?" che, per la modalità con cui viene formulata, ci sembra voglia significare "perché questa sofferenza o questa condizione?". Al rientro della donna nel vagone sopraggiunge il controllore, che le chiede il biglietto; la donna mostra al controllore tre biglietti a chilometraggio limitato non obliterati, per cui l'uomo le domanda dove sia diretta; la donna visibilmente confusa ripropone l'interrogativo al controllore: "Dove devo andare? Dove sono diretta?" e con un tono angosciato e smarrito "Da dove sono partita?". ll controllore decide per lei e convalida i biglietti per la fermata
di Messina; questa scelta appare gradita alla donna che può così apprendere quale sarà la sua prossima tappa. Il momento temporaneo di smarrimento, nella sua condizione di "perenne girovagare", sembra passato, e può così tornare nello spazio di transito dei vagoni al suo rituale canoro. Giunti a destinazione, la donna, affacciandosi dal finestrino, vede alzarsi in volo cinque piccioni, spaventati dal passaggio del treno, ed esclama ripetendolo incessantemente: "Cinque piccioni" cercando febbrilmente tra i suoi bagagli fin quando trova un orologio: inizia così a ripetere ritmicamente l'orario letto nel quadrante; tale ripetizione cessa improvvisamente con una frase: "Cinque piccioni mandati dal Signore alle undici e quarantacinque in punto per la Suora Nera".
- "Attraversamenti" agevoli, "interazioni" rapide, "servizi" efficienti, sebbene siano il prodotto di un
adeguamento alle esigenze civili, sociali e di sviluppo, alimentano d'altra parte una "cultura della velocità" che catalizza e parallelamente accentua i processi di anonimizzazione del territorio: la fruibilità dello spazio rischia così di non congiungersi ad una storica e significativa interiorizzazione dell'espansione della città. E il rischio di un impoverimento relazionale e soggettivo diviene spesso ancor più ingannevole in quei luoghi eterotopici (Foucalt M., 1994) di aggregazione in cui la convinzione illusoria di autentici scambi ed incontri viene camuffata ed annebbiata da pseudo-relazioni che non pemettono una reale crescita soggettiva ed intetpersonale; tali riflessioni sono emerse anche attraverso un altro incontro accaduto durante la ricerca, quello con "l'Albero Totemico" di Carmelo. Da anni chi frequenta la zona della Stazione Marittima di Messina
conosce la singolare figura di Carmelo. Carmelo ha trentotto anni. e originario di un paese della costa orientale della Sicilia, ed uno degli homeless che da anni hanno individuato in tale stazione un "luogo di riferimento", dove racimolare qualche spicciolo per le sigarette e qualche bottiglia di vino. Per questa drammatica condizione condivide alcuni comportamenti e disagi di chi vagabonda per le città; Carmelo però colpisce per una sua particolare predilezione per un albero che si trova in una delle aiuole all'interno della stazione; l'albero, un abete, in apparenza simile agli altri abeti che si trovano nella stessa zona, è diventato insieme allo spazio che lo circonda un fondamentale punto cardine nella vita di Camelo, un "soggetto sacro" davanti al quale inginocchiarsi, pregare, dormire. Carmelo ha sviluppato nel tempo un particolare sentimento di proprietà e protezione nei confronti dell'albero, del quale si prende costantemente cura, caratterizzato talvolta anche da
modalità aggressive e violente verso chi invade o deturpa quel suo spazio sacro: raccoglie le foglie e i rami secchi caduti custodendoli gelosamente o rendendoli parle di alcuni suoi rituali, e circonda il suo albero-totem con sassi, foglie, rami, con i quali forma dei cerchi o i confini di sentieri che portano al suo luogo di culto.
Carmelo parla con il suo albero, forse confida i suoi "segreti" o le sue sofferenze, e forse in esso ha trovato quelle radici o quel contenitore della sua identità non individuati altrove.

null
A LUCI SPENTE LA CITTADINANZA COME ESPERIENZA DI ESCLUSIONE
-
Il presente contributo si inserisce nell'ambito di quel filone di ricerca che studia l'individuo nel suo contesto fisico e sociale mediante un modello volto all' individuazione delle interrelazioni tra l'uomo e il suo ambiente, esplorando percezioni, rappresentazioni, atteggiamenti e valutazioni del contesto socio-territoriale nonché le dimensioni psicologiche sottese agli atteggiamenti e alle condotte ambientali che li accompagnano. Il nostro lavoro ha considerato i "modelli" proposti e le declinazioni assunte dal "sentimento/vissuto di cittadinanza" negli interventi di volontariato sociale realizzati nella città di Palermo e rivolti a soggetti (ed a "luoghi") definiti "a rischio di marginalità e di violenza" con la finalità di esplorare, con vertice psicodinamico, quali modelli di integrazione/marginalità sociale siano implicitamente attivi negli interventi di Volontariato "istituzionalmente" preposti all'incremento del "sentimento di Cittadinanza" sociale di fasce territoriali e di popolazione considerate "a rischio". L'ipotesi da noi formulata è che la presenza di rappresentazioni che condividono uno stereotipo sociale (e, potremmo aggiungere, territoriale) influenzi la possibilità che le azioni sociali di volontariato rivolte a soggetti a rischio diventino generatrici di pregiudizio. Dall'analisi qualitativa dei dati, raccolti attraverso la realizzazione di focus groups (cui hanno partecipato volontari e destinatari degli interventi),di interviste a 'testimoni privilegiati' (ossia figure che per la loro posizione professionale hanno offerto una visione particolare del fenomeno oggetto di studio) e la lettura critica delle resocontazioni delle attività svolte, è emerso che: ad azioni di volontariato improntate a modelli capaci di accogliere e contenere le diversità che attraversano soggettività, appartenenze, disagi e bisogni, prefigurando la possibilità di un cambiamento dei modelli di cittadinanza attraverso la condivisione empatica, si accompagnano interventi (improntati all'unipolarità ed autoreferenzialità) che spesso configurano una proposta di cittadinanza legata a dimensioni stereotipe che rendono difficoltoso il processo di integrazione psico-socio-territoriale e la
decostruzione del pregiudizio sociale e della marginalità che, talvolta, ne è diretta conseguenza; il problema dell'identità sociale e della strutturazione del concetto di sé, tanto per i volontari quanto per gli utenti, si intreccia indissolubilmente con dalla categorizzazione semantica di determinati quartieri quali "quartieri a rischio" e la messa in atto di dinamiche di tipo collusivo; rigidità e pregiudizi rispetto a identità, ruoli sociali, realtà territoriale e ambientale, condivisi da operatori ed utenti, diventano vincolo per un adattivo dialogo
intersistemico ed interpersonale, esprimendosi in modalità relazionali che appaiono pregiudiziali e fisse, nelle quali non c'è spazio per il "nuovo" che l'utente, l'istituzione, il volontario possono portare "in" e "con" sé. Le ricadute operative riguardano la possibilità di elaborare modelli di intervento che consentano al variegato sistema di agenzie, pubbliche e del privato sociale di realizzare l'incontro tra soggettualità e ambiente imprescindibile per incrementare quel "sentimento di Cittadinanza" attivatore di cambiamento.
Punti Chiave - Si è subito evidenziata, sin da una prima analisi del materiale raccolto, la trasversale "emergenza" (nella duplice accezione di "venire all'attenzione" e di "urgenza") di alcune questioni fondamentali quali: la questione della categorizzazione sociale del target dell'utenza degli interventi, apparsa strettamente legata alla "categorizzazione territoriale" degli stessi; quella della collusione-collisione tra rappresentazioni e l'immaginario degli organizzatori delle diverse azioni di volontariato e gli operatori da un lato e quelle degli utenti dall'altro; l'ambivalenza di vissuti relativi ai luoghi ed agli stessi soggetti coinvolti.
- La questione della categorizzazione sociale (Tajfel, 1963, in Smith e Mackie, 1998) e territoriale dei destinatari degli interventi di prevenzione-promozione quali soggetti "marginali" si intreccia indissolubilmente con il problema dell'identità sociale e della strutturazione del concetto di sé. Come sottolineano Smith e Mackie (1998) la <<consapevolezza di appartenere a determinati gruppi può essere attivata da stimoli diretti, come le etichette di gruppo .... e per alcuni individui l'appartenenza di gruppo assume una rilevanza....una volta attivate, le conoscenze relative ad un'appartenenza di gruppo producono molteplici effetti sul concetto di sé e dell'autostima, in quanto vi è la tendenza a considerare se stessi come rappresentanti tipici di un gruppo>>'e quanto le rappresentazioni di sé e dell'altro siano influenzate, ad esempio, dalla categorizzazione semantica di determinati quartieri quali "quartieri a rischio" ci viene narrato da un gruppo di utenti di uno dei tanti interventi di "promozione sociale" durante una sessione di focus group: durante la fase di drammatizzazione i ragazzi hanno deciso di mettere in scena il modo in cui sono stato cornvolti in tale iniziativa. La scena inizia con una sorta di reclutamento fatto per le strade del quartiere X <<un quartiere tristemente noto>>; questo reclutamento viene effettuato, nella drammatizzazione, utilizzando come unico criterio di selezione 'la residenza nel quartiere X piuttosto che Y', criterio visibilmente esplicitato dalle frasi degli attori-volontari: <<Dove abiti? Abiti lì? Ok allora sei "a rischio", fai al caso nostro!>>.
- Dai racconti appare visibile l'esistenza di un vissuto di disagio nei ragazzi, una sorta di fastidio nell'essere considerati "diversi dagli altri" ma, nello stesso tempo, arriva chiaramente la messa in atto di dinamiche di tipo collusivo con quella rappresentazione della "marginalità" che, se da un lato rimanda a dinamiche psicosociali che relegano il soggetto (collettivamente inteso) in una posizione periferica rispetto alla centralità occupata dalla maggior parte dei soggetti, dall'altro rimanda a conseguenti dinamiche di auto ed etero inclusione ed esclusione relativamente alla fruizione di determinate risorse o privilegi (istituzionali, formative, lavorative,sociali, etc.) o, ancora, alla possibilità/impossibilità di "vivere la cilladinanza" come qualcosa di non restrittivamente coincidente (nell'immaginario di tali soggetti) con il vivere il loro quartiere "di appartenenza". Di fatto, l'auto ed etero attribuzione di una tale "identità sociale specifica" al complesso di individui che condividono la caratteristica socialmente significativa (Tajfel e Tumer, 1976, in Smith e Mackie, 1998) di
"appartenere a determinati quartieri", genera un appiattimento delle differenze tra gli individui inclusi nel gruppo e getta le basi della stereotipizzazione.
- Le rappresentazioni sociali relative alle "condizioni di disagio sociale di alcuni gruppi residenti in particolari territori" si riverberano nella scelta dei modelli di íntervento e nelle fasi di ideazione e progettazione delle azioni di sviluppo sociale. Rispetto al materiale raccolto sembra esserci una prevalente sintonizzazione dei responsabili/progettisti degli interventi e dei volontari su "aspetti oggettivi negativi" (quali ad esempio la situazione socio-economica delle famiglie di provenienza o i negativi trascorsi scolastici degli utenti) e tale
fattore potrebbe rivelarsi una variabile "pesantemente intenzionante" relativamente alle premesse esplicite fondanti i progetti, ed orienta implicitamente la realizzazíone di alcune iniziative. Nel racconto degli stessi operatori, alcuni progetti pensati, ad esempio, con esplicite finalità formative, non rispondono né a reali esigenze di mercato, né ai bisogni degli utenti; di fatto la maggior parte delle offerte previste sembrano ideate per destinatari con scarsissime competenze di base, quasi fosse impossibile pensare per questo target una 'alta qualificazione', senalando l'esistenza di una difficoltà da parte degli organismi preposti nel cogliere i bisogni della popolazione considerata;
- La devianza nelle zone "disagiate" del territorio urbano può in parte esprimere la fascinazione perversa della coartazione unipolare nelle rappresentazioni e nelle simbolizzazioni dei contesti e del sociale da parte degli abitanti stessi di quel territono. Nei quartieri in cui l'insoddisfazione (ed il distanziamento) sociale appaiono evidentemente pregnanti, le proposte di intervento e di modifica della realtà (in primis quella urbana e socioeducativa) e dei modelli di convivenza rischiano di scontrarsi con regole interiorizzate rigidamente
prescrittive-proscrittive. Il "disagio" (in un'accezione più antropologica che fenomenica) può trovare paradossalmente un riflesso/specchio proprio nell'azione dei volontari deputati ad intervenire su questo, qualora fantasie pregiudiziali o stereotipe dell'operatore "colludano" con l'autorappresentazione dell'utenza o con l'etichettamento sociale: si esprime in tal modo quella peculiare condizione di "territorio come destino" che imbriglia le potenzialità di sviluppo di un sentimento di cittadinanza condiviso e condivisibile nelle sua
pluralità e complessità, e che sembra invece quasi promuovere modelli e criteri di stampo assistenzialistico fondati su categorizzazioni del territorio meramente adesive ad uno stereotipo sociale, e che attraverso fantasie e prassi a carattere normativo e/o salvifico rischiano di promuovere "dipendenza" piuttosto che "autocommittenza".

null
PSICODINAMICA DELLA GRAVIDANZA IMMAGINARIO DEL PARTO E ANGOSCE DI MORTE
-
M. Russo
Dipartimento di Psicologia, Palermo
Introduzione
Duplice è la finalità perseguita nella presente ricerca:
1 - l'esplorazione dei vissuti
delle donne gravide e del loro immaginario del parto
2 - la formulazione di possibili ipotesi volte al sostegno ed alla tutela della "salute" psicologica delle gestanti e del nascituro
Crescente è stata negli ultimi anni 1'attenzione rivolta verso i vissuti e le dinamiche psicologiche delle gestanti, non solo in ambito strettamente psicologico, ma anche in ambito medico e della psicoprofilassi ostetrica. Tuttavia, proprio negli ultimi anni si è dato
spazio più a tecniche di tipo "ortopedico" volte all'alleviamento del sintomo parto difficile ma non all'elaborazione e dei vissuti ad esso connessi. Ed è proprio in quuest'ultima direzione che si muove la presente ricerca.
Metodo
Il campione coinvolto per la realizzazione della ricerca è costituito da 130 donne tra il 6° ed il 9° mese di gravidanza.Esso è stato selezionato tramite adesione spontanea dopo un primo contatto all' interno di corsi per la preparazione al parto.
GIi strumenti che sono stati utllizzazti per la rilevazione dei dati sono : focus group, questionario, semistrutturato, differenziale semantico,osservazioni cliniche.
Il focus group è un colloquio in profondità, che attraverso modalità poco intrusive e l'uso di materiale stimolo costruito ad hoc, consente l'emergenza di contenuti latenti relativi al tema in oggetto; le osservazioni cliniche fanno riferimeno all'annotazione dei principali indicatori psicodinamici; il questionario è stato appositamente costruito tenendo conto delle principali aree d'interesse relative alla psicodinamica della gravidanza, lasciando spazio anche a quelle aree a noi "ignote" fondamentali per ulteriori sviluppi degli studi sul tema in oggetto. I1 differenziale semantico è uno strumento psicometrico largamente utilizzato per la misurazione dei significati ipliciti nei concetti, ovvero l'individuazione delle dimensioni concettuali latenti dei giudizi espressi dai soggetti, prescindendo dagli aggettivi usati per esprimere tali giudizi. Per l'analisi dei dati sono stati utilizzati i più comuni indici statistici (percenruali. r di pearson, ecc.); per l' analisi del contenuto è stata utllizzata una griglia appositamente costruita.L'analisi del contenuto consente , tramite la semplificazione e la categorizzazione delle modalità comunicative dei soggetti, il trattamento statistico dei dati.
Conclusioni
Vorrei, in primo luogo, sottolineare come i risultati siano il prodotto di una ricerca pilota condotta con un numero relativamente esiguo di gestanti, eterogenee per periodo di gestazione. Le riflessioni non sono pertano generalizzablli a tutto l'universo delle gestanti, ma utillizzablli come risultati di natura qualitativa da utllizzare come base per ulteriori e necessari approfondimenti. Sarebbe utile, ad es.,la relizzazione della stessa ricerca con campioni diversificati per periodi di gestazione o con gestanti single. Inoltre, tenuto conto dei risultati sarebbe ipotizzabile la realizzazione di corsi per l'elaborazione dei propri vissuti, topoi mentali che attivino processi trasformativi del pensiero, dove poter pensare, ad es., al parto come ad un "invento" (nell'accezione di Di Maria f., Lo Verso G., 1995) e non come un evento (ex-venio)inesorabilmente incombente dall'esterno.
Riferimenti bibliografìci
Di Maria F., Lo Verso G. (1995), La psicodinamica dei gruppi. Trattato di teoria e tecniche. Corfina. Milano.
Di Maria F. (1992),La relazione interpersonale tra accadimento ed invento, in Di Nuovo
S., Moderato ., La psicologia oggi tra indagine sperímentale e ricerca
sociale e clinica. Cuem. Catania.
Scabini E. (1998), I1 primo figlio: le attese, le sorprese, in Psicologia Contemporanea,
gen-feb, n.145,
Veggetti Finzi S., Il Romanzo della Famiglla, Mondatori, Milano.

null
STEREOTIPI E PREGIUDIZI NELLA FORMAZIONE PER I SOGGETTI A RISCHIO DI MARGINALITA' E/O VIOLENZA : LA CITTADINANZA COME ESPERIENZA DI ESCLUSIONE
Maria Russo e Valeria Tullio
-
Il tema del rischio "marginalità" e delle sue ingenti conseguenze da tempo ha suscitato l'interesse degli studiosi di molte discipline; tale problematica, infatti, raccchiude in sé diversi aspetti che attraversano, e sono attraversati da, i mondi del familiare, della scuola, dell'economia, del lavoro, della legalità etc; la psicologia sociale, specificatamente, ha a tal proposito focalizzato la propria attenzione sulle molte e diversificate caratterizzazioni territoriali che questo fenomeno assume. ln particolare,
nel territorio palermitano, luogo scelto per questo lavoro di ricerca, molti sono gli elementi che intersecandosi generano e alimentano la manifestazione di dinamiche di
marginalità e/o esclusione sociale. A tal proposito si è assistito ad un proliferare di attività di prevenzione volte a diminuire il rischio di violenza tra i giovani, tali attività vengono svolte a più livelli e indirizzate a diverse fasce d'età: ai bambini ed agli
adolescenti, attraverso interventi realizzati nelle scuole e nell'area socio-ricreativa;
nonché ai giovani, soprattutto attraverso la realizzazione di corsi di formazione professionale. Ma questi interventi di prevenzione sono realmente adeguati alla popolazione target che intendono raggiungere? Nell'ambito di tale interrogativo si inserisce la nostra ricerca, la cui Finalità è stata l'esplorare, con vertice psicodinamico, quali modelli di integrazione/marginalità sociale siano implicitamente attivi negli interventi cittadini di Formazione, istituzionalmente preposti all'incremento della cittadinanza sociale di fasce considerate a rischio di marginalità e/o violenza. Gli obiettivi principali sono stati rivolti a: l) l'esplorazione dell'influenzamento tra le diamiche territoriali attivate dagli organi preposti alla formazione dei giovani e l'emergenza di dinamiche di marginalità; 2) l'esplorazione dei modelli di integrazione-marginalità sociale veicolati dagli interventi di Formazione destinati ai giovani; 3) l'individuazione di modelli di intervento realmente orientati all'attivazione di azioni di sviluppo sociale nel territorio palermitano.
L'ipotesi guida è che la presenza di rappresentazioni che condividono uno stereotipo sociale nei gruppi di appartenenza, influenza la possibilità che le azioni sociali di prevenzione con soggetti a rischio diventino generatrici di pregiudizio. I presupposti metodologici di questo lavoro sono quelli propri della ricerca-intervento. I soggetti coinvolti nella ricerca, residenti in zone della città di Palermo scelte per le loro peculiari caratteristiche socio-economico-culturali, sono stati: a) gruppi di bambini di età compresa tria i 7 e i l0 anni frequentanti le scuole elementari: b) gruppi di adolescenti di età compresa tra gli ll e i l4 anni frequentanti le scuole medie inferiori: c) gruppi di giovani di età compresa tra i l5 e i 25 anni frequentanti corsi di formazione professionale realizzati nel palermitano: d) gruppi di genitori: e) gruppi di docenti delle scuole elementari: f) gruppi di docenti delle scuole medie inferiori; g) testimoni privilegiati, ossia figure che per la loro posizione professionale possono offrire una visione parlicolare del fenomeno oggetto di studio (coordinatori di C.F.P., direttori didattici, preti ecc.) La rilevazione dei dati è stata effettuata attraverso i seguenti strumenti: interviste con questionario a risposte aperte inerenti le tematiche dei suddetti obiettivi; focus groups; gruppi di animazione ludica con attivazioni psicodrammatiche condotti con i soggetti della ricerca; racconti psicoautobiografici. I dati emersi sono stati elaborati qualitativamente sia attraverso griglie di lettura che ne hanno consentito la categorizzazione e l'interpretazione, sia
attraverso i comuni indici di statistica descrittiva. I risultati sembrano confermare l'ipotesi di partenza: tra i più significativi possiamo sottolineare la presenza di dinamiche espulsive e di controllo che, insierne alla disconferma delle potenzialità dei soggetti " a rischio", concorrenti alla determinazione di etichettamenti attentano, anziche favorirla, l'integrazione sociale. Ricadute Operative: tra le ricadute più rilevanti si evidenzia l'attivazione di Gruppi di Formazione, focalizzati sull'acquisizione della collsapevolezza relativa alla messa in atto di dinamiche veicolanti "chiavi" di lettura del "reale" stereotipate, e che hanno coinvolto gli Operatori partecipanti agli interventi compresi nel piano di osservazione realizzato dalla ricerca, ovvero figure operanti nell'ambito della scuola e dell'area socio-ricreativa. Alla luce dei risultati ottenuti, un interessante sviluppo della ricerca potrebbe essere rintracciabile nell'analisi delle stesse dinamiche in tessuti sociali situati nelle aree centrali e settentrionali del territorio nazionale, nonché nelle isole minori della Sicilia (Pantelleria, Ustica. ecc .). poiché si tratta di territori la cui dinamica socioistituzionale ed economica si configura in modo peculiare.

null
ON THE SEA SIDE OF MEDITERRANEAN, THE PROCESS OF "MULTICULTURAL
RELATIONAL CITIZEN" IN TWO HARBOUR COMMUNITIES
A.Piazza, R. Favaloro, M. Russo
Department of Psychology, University of Palermo/Italy
-
Our research, by a psychodynamic stand point, explored through interviews and questionnaires the imaginary of two harbour territorial communities of the Mediterranean (in Sicily Isola delle Femmine on the south Tyrrhene and Porto Empedocle in Sicily's Channel) in comparison with the share of traditional works with immigrants coming from African Countries, involving in particular, the employees of seafaring activities (fishing, fish trade and preservation of fish) and their families. The presence of politics of local growth aimed at the socio-cultural exploitation of traditional works constitutes itself as facilitating principle of the pluriethnic relational citizen and consents the foundation of coherent patterns of psychosocial interventions.
TRADUZIONE
Sul lato mare del Mediterraneo, il processo di "MULTICULTURALE
CITTADINO relazionale "in due comunità PORTUALI
Piazza A., Favaloro R., M. Russo
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Palermo/Italia
-
La nostra ricerca, da un punto di vista psicodinamico, esplorato attraverso interviste e questionari l'immaginario di due comunità territoriali porto del Mediterraneo (in Sicilia, Isola delle Femmine, a sud, Tirreno e Porto Empedocle nel Canale di Sicilia) in confronto con la percentuale di opere tradizionali con immigrati provenienti da Paesi africani, coinvolgendo in particolare, i dipendenti di attività marinare (pesca, il commercio di pesce e la conservazione del pesce) e le loro famiglie.
La presenza di politiche di sviluppo locale finalizzati alla valorizzazione socio-culturale di opere tradizionali si costituisce come principio di agevolare la plurietnica relazionale cittadino e consente il fondamento di modelli coerenti di interventi psicosociali.

null
Dalla multimedialità alla multidisciplinarietà: il linguaggio tecnicistico nel lavoro d'equípe
Introduzione
All'interno della vasta letteratura sulla psicopatologia favorita dalla comunicazione manipolativa nella società attuale, si riscontra una produzione scientifica relativamente poco specifica in relazione all'incidenza dell'uso del linguaggio tecnicistico nei contesti
sanitari. Come suggerisce Galimberti, "L'etica celebra la sua impotenza nel mondo della tecnica regolato dal fare come pura produzione di risultati [...]. Ciò significa che non è più l'etica a scegliere i fini e ad incaricare la tecnica di reperire i mezzi, ma è la tecnica che, assumendo come fini i risultati delle sue procedure, condiziona l'etica, costringendola a prendere posizione su una realtà che la tecnica non cessa di costruire e rendere possibiìe [...]. Nel monologo collettivo proprio dei tempi più recenti l'esperienza della comunicazione crolla, perché è abolita la differenza specifica tra le esperienze personali del mondo che sono alla base di ogni bisogno comunicativo" (Galimberti, 1999). Eppure, proprio queste differenze specifiche soggettive fondano un efficace lavoro d'équípe multidiplinare, capace di cogliere la differenza come risorsa. Da ciò ha preso le mosse il nostro lavoro di ricerca.
Finalità
La nostra ricerca, di tipo qualitativo a vertice psicodinamico, ha avuto come finalità l'esplorazione delle dinamiche relazionali e dei vissuti caratterizzanti gruppi di lavoro peculiari quali le équipe multidisciplinari; in particolare, obiettivo della ricerca è stato l'esplorarione della valenza che l'uso di termini troppo tecnici assume rispetto alla percezione degli operatori della salute riguardo la propria identità professionale: inoltre si è indagato su come le difficoltà relazionali, causate e/o prodotte dall'uso di un linguaggio multimediale eccessivamente tecnicistico, possano vincolare la relazione con l'utenza.
Ipotesi
L'ipotesi della nostra ricerca è che l'uso di un linguaggio multimediale tecnicistico da parte dei diversi operatori influenzi la qualità del lavoro di staff configurandosi come dispositivo difensivo ostacolante i processi comunicativi intersoggettivi.
Rilevazione dei dati: soggetti e strumenti
La ricerca/intervento ha coinvolto operatori di differente estrazione professionale (medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, insegnanti,ginecologi) operanti all'interno delle AUSL, delle scuole e delle aziende ospedaliere, istituzionalmente "costretti" a riunirsi in équipe, spesso sporadicamente e con tempi molto veloci, per resocontare e condividere uno spazio al fine di perseguire obiettivi comuni. Gli strumenti utilizzati sono stati il colloquio gruppale, attivazioni psicodrammatiche, un questionario appositamente costruito e l'osservazione all'interno delle riunioni periodiche d'équipe.
Elaborazione dei dati
L'elaborazione dei dati è stata attuata attraverso griglie qualitative costruite appositamente e l'uso di indici di statistica descrittiva.
Risultati
I risultati compongono un quadro complesso, contraddistinto da una comune, ma taciuta, difficoltà a confrontarsi con professionalità diverse. Gli operatori manifestano, più o meno consapevolmente, una paura celata ma presente di perdere o con-fondere la propria identità professionale. Sembra difficile stabilire dei confini tra Sé ed Altro nell'istituzione (o forse proprio convivere nel topos del confine), se non quelli difensivi della chiusura o dell'uso di termini tecnici. Si è evinta, inoltre, un'impermeabilità alle risorse provenienti da professionisti differenti vissuti come potenzialmente minacciosi rispetto alla stabilità della propria identità professionale. L'uso di un linguaggio multimediale eccessivamente tecnico sembra poter esser letto, dunque, come modalità di affermazione della propria identità nei sui aspetti più legati all'area dell'efficienza e del tecnicismo, polarizzata più sul versante dell'informazione e della chiusura, che della comunicazione e della condivisione. Tale modalità si configura come rigida e spesso manipolativa, in quanto mira a creare delle posizioni rigidamente gerarchiche, per mettere ordine alla complessità della relazioni complementari proprie di un'équipe multidisciplinare, cadendo così nel circuito collusivo del concepimento e mantenimento di rappresentazioni di ruolo difensive e statiche. Tramite l'uso di linguaggio tecnico sembra che passi una difficoltà di affidamento e condivisione con l'équípe, specchio di ansie legate a quelle aree emotivamente e/o affettivamente più investite. Tali dinamiche investono e vanno in qualche modo ad influenzare la relazione con l'utenza, alla quale spesso viene proposto un modello relazionale e di intervento scisso e parcellizzato.
Ricadute operative
Tra la ricadute operative ci limitiamo ad evidenziare in questa sede la costruzione di un modello che favorisca l'opportunità di maggiori spazi di confronto e condivisione, dove sia possibile una elaborazione dei conflitti e delle difficoltà ma anche una sintonizzazione ed una accoglienza di tempi, modelli, soggettività differenti.

null
I siti web sulla salute: quando la "rete" è una trappola
Bianca Longo, Gabriele Ajello, Gabriella Giannì, Maria Monforte, Maria Russo
Dipartimento di studi su Politica, Diritto e società (DPDS),Università di Palermo
Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo
Introduzione
Appare sempre più evidente il ruolo della comunicazione di massa nel campo della vendita di beni e servizi sui mercati, e come i metodi di "persuasione occulta e non" abbiano investito anche la salute e il desiderio collettivo di salvaguardarla a tutti i costi.
In particolare,le strategie di tutela della salute vengono fortemente condizionate dall'impatto dell'informazione divulgativa sulla salute laddove più a repentaglio è il controllo delle fonti di detta informazioni, cioè sul web.Internet è attualmente il luogo dove la divulgazione
medica e della salute riesce ad aggirare quel sano muro di sfiducia che eviterebbe al paziente di cadere nella trappola di sedicenti cure miracolose contro una certa malattia.
A fronte di una grande proliferazione di siti per le consultazioni mediche (più di 100 mila in tutto il mondo), pochi sono quelli che forniscono consigli adeguati per la cura dei disturbi fisici e/o psichici e molti altri possono risultare lacunosi, incompleti, se non addirittura pericolosi. Da tali considerazioni ha preso le mosse la nostra ricerca.
Finalità
La finalità della ricerca qui resocontata è stata, alla luce di tutti questi aspetti, quella di analizzare criticamente i siti web, rispetto ai requisiti stabiliti dagli organismi che propongono un regolamento deontologico per la comunicazione sanitaria on line.
Ipotesi
L'ipotesi della ricerca è che il linguaggio presente nei siti web che offrono contenuti riguardanti la salute sia proposto appositamente in modo tale da far risultare molto complesso valutare la giusta attendibilità delle informazioni riportate sui siti web. Chiunque può riportare notizie false o manipolate, celando o alterando la propria identità. La navigazione rimane a totale rischio dell'utente che, spesso, si trova impreparato.
Rilevazione dei dati: soggetti e strumenti
L'analisi è stata di tipo squisitamente qualitativo, rispetto ai contenuti trattati, e ha previsto il controllo di alcuni parametri per i quali è stato stabilito un valore utile alla comparazione.
A partire da queste considerazioni la ricerca ha effettuato, per un lungo periodo di tempo, una comparazione di circa una ventina di siti tra i più rappresentativi scelti in base a quelli che l'utente trova più facilmente attraverso l'accesso dai più comunì motori di ricerca. Proprio perché di tipo squisitamente qualitativo,l'analisi effettuata ha preso in considerazione le caratteristiche salienti del sito,senza entrare nel dettaglio di aspetti tecnici.
Elaborazione dei dati
L'elaborazione dei dati è avvenuta mediante griglie di gerarchizzazione dei parametri
considerati, costruite ad hoc,ed attraverso l'uso degli indici di statistica descrittiva.
Risultati
Secondo il Censis, sono 4 milioni i navigatori che cercano informazioni sulla salute; di questi il 60,2% si fida delle informazioni in rete (il 75% tra i più giovani), il72,9% valuta positivamente l'uso di Internet da parte dei medici (l'84% tra i più giovani) e 20 mila, infine, sono le specialità di farmaci acquistati on line. Non stupisce, quindi, che la medicina on Iine sia al secondo posto, per numero di accessi, sui motori di ricerca, dopo il porno.
La struttura stessa dei siti esaminati, rappresentata dalla sua organizzazione logica, riflette un'idea chiara sugli scopi del sito; inoltre, se è chiara e coerente, favorisce la facilità d'uso del sito; per ciò che concerne la valutazione della "completezza dell'informazione", cioè se i contenuti offerti sono adeguati al raggiungimento degli obiettivi e se il sito possiede la capacità di essere facilmente ricordato e riconosciuto, l'impressione è che la rete accoglie tutto al suo interno e che sia una realtà altamente complessa, nel senso che in essa convivono potenzialità infinite per la comunicazione. Per questa ragione, risulta cruciale il grado di esplicazione e controllo con cui sono attivi i seguenti parametri: l'espressa indicazione delle credenziali; l'indicazione della finalità del sito; la corrispondenza del contenuto alle finalità (vengono evidenziate eventuali discordanze e/o ridondanze); la fonte del contenuto; la qualità dei link connessi al sito stesso; la presenza o meno di sezioni di divulgazione separate per operatori medici e di divulgazione medico-scientifica aperta al pubblico; la data di aggiornamento delle informazioni; la permanenza on-line delle pagine (se poi devono essere rimosse); l'aspetto grafico, struttura e navigabilità del sito.
Ricadute operative
Nel realizzare questa ricerca, ci siamo proposti di utilizzare, quasi esclusivamente materiale reperibile in rete. Una ricaduta operativa del nostro lavoro è stata la predisposizione di criteri basilari che consentano di difendersi dalle informazioni mediche approssimative.
Un modello utile cui ispirarci ci sembra possa essere la certificazione di qualità rilasciata dalla Health on the Net Foundation, una fondazione svizzera no profit che fa riferimento all'Università di Ginevra. Sono stati loro, per primi, a ideare i "bollini blu" di garanzia che assicurano la qualità dei siti sulla salute. Le regole da seguire per ottenerli sono precise: indicare credenziali, nome, telefono e recapito dell'autore, riferimenti bibliografici delle informazioni fornite e data dell'ultimo aggiornamento del sito.

null
La funzione di Resilienza nella Cura (1/2)
A. Piazzn, V. Tullio, S. Oteri, M. Russo
-
In letteratura il costrutto di Resilienza (resíliency) viene definito come la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici (malattie, traumi, eventi stressanti, catastrofi etc.), ovvero la potenzialità di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. La "resilienza" è una funzione psichica che si modifica nel tempo in rapporto con l'esperienza, i vissuti e, soprattutto, con il modificarsi dei meccanismi mentali che la sottendono; come un processo, un insieme di fenomeni armoniosi grazie ai quali il soggetto si introduce in un contesto affettivo, sociale e culturale. Essa non si acquisisce una volta per tutte, ma rappresenta un cammino da percorrere: l'esistenza è costellata da prove, ma la resilienza e l'elaborazione dei conflitti consentono, nonostante tutto, di continuare il proprio percorso di vita. La resilienza può essere considerata una risposta complementare alla presa in carico e cura della vulnerabilità di un soggetto, permettendone una differente modulazione (Anthony,2004); comprendere le implicanze di tale costrutto nel processo di cura può consentire all'operatore di aiutare il paziente nel difficile, quanto indispensabile, processo di trasformazione di un evento critico e destabilizzante in motore di sviluppo personale. Parafrasando Scala(1998), possiamo affermare che "ogni percorso di presa in carico è un cammino condotto da persone (gli operatori) con persone (i pazienti e i loro familiari) verso una meta comune (la cura)" e affinché ciò accada è indispensabile che si costruisca una relazione di fiducia tra l'operatore e l'utente. In tale prospettiva epistemologica, assumono particolare rilievo le caratteristiche fondanti la relazione e la comunicazione operatore/paziente. Se è vero che la resilienza è una caratteristica/capacità altamente soggettiva, è altrettanto vero che esistono possibilità di sviluppare questa risorsa personale e sociale presente in latenza in ogni individuo; potenziare questa forza interiore, tanto negli operatori quanto nei pazienti può significare elevare il livello generale di salute e qualità della vita implementando nei soggetti la capacità di reagire ai colpi della vita, di risollevarsi e di ricostruirsi. Secondo Stefan Vanistendael, sociologo, e Jacques Lacomte, il processo di resilienza sarebbe facilitato da due fattori che interagiscono tra di loro. Il primo è quello della memoria: un individuo che tende a rimuovere la sofferenza vissuta o a banalizzarla, difficilmente riesce a superarla. Riconoscere la propria sofferenza e riconoscersi dunque come "feriti" rappresenta il primo passo verso la ricostruzione di sé. L'altro fattore è quello della condivisione: la condivisione delle proprie difficoltà, inizialmente, e del processo di rinnovamento, in seguito. Attorno al costrutto di resilienza convergono, inoltre, diversi fattori o attitudini: temperamentali, familiari, sociali, culturali, educativi, spirituali. E' possibile in tal modo individuare almeno tre dimensioni fondanti della resilienza: 1) biologica, che sottolinea il ruolo del patrimonio genetico: alcuni hanno energie maggiori di altri; 2) psicologica, che evidenzia l'importanza delle relazioni che si formano nell'infanzia e che consentono di strutturarsi come persona capace di reagire per far fronte alle avversità(attaccamento, comunicazione, competenze, modelli di riferimento); 3)sociodinamica, che mette in evidenza l'influenza del gruppo, della cultura, degli apprendimenti, delle tradizioni familiari, della spiritualità, dell'etica sulla capacità dell'essere umano di attraversare le crisi dell'esistenza vivendo, malgrado tutto, una vita, non certo semplice, non priva di sofferenza, non sempre equilibrata, ma piena. La cultura rappresenta, dunque, una matrice fondamentale non solo per comprendere, diagnosticare e curare la sofferenza psichica, ma anche per capire e glenerare le condizioni di benessere soggettivo, ovvero la valutazione della propria esistenza in termini sia di soddisfazione di vita (valutazione cognitiva), sia di condotte emotive positive(valutazione affettiva), (Diener e Diener, 1995). Insieme ai fattori sociali ed economici (cosiddetti oggettivi), il benessere soggettivo è alimentato da una serie importante di processi psicologici. Essi variano in modo sistematico a seconda della cuitura di riferimento. Molti individui si ammalano della stessa malattia, ma con decorsi ed esiti spesso molto diversi, che non vengono adeguatamente spiegati né da fattori fisici né da differerrze di contesti oggettivi o ambientaii. Da qui il ricorso a fattori esplicativi psicologici di tipo individuale soggettivo. Il concetto di recovery, apparso per la prima volta negli anni '80, presenta molteplici aspetti di congiunzione con la resilienza; si identifica, infatti, con lo sviluppo di potenzialità personali e col recupero di ruoli nella società per soggetti con problemi di natura psichiatrica. Per questi stessi utenti psichiatrici riprendersi significa sviluppare, in modo profondamente personale e unico, nuovi significati e propositi man mano che si apre la possibilità di rievolversi oltre la catastrofe della malattia mentale (Anthony 1993); significa fronteggiare gli eventi quotidiani utilizzando anche gli opportuni sostegni, e riconoscendo l'esistenza dei propri deficit, ma anche ammettere la presenza di punti di forza e di capacità di recupero. Il concetto di resilienza si propone di comprendere e spiegare se e come sia possibile elaborare percorsi piuttosto che progetti o azioni rivolte alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita. Boris Cyrulnik (2005) scrive:
"Quando comprenderemo qual è il processo che mette fine ad un'agonia psichica e permette il ritorno alla vita, potremmo aiutare meglio i feriti nell'anima e forse rimettere in discussione i nostri principi educativi" . Oltre alla resilienza individuale, gli studiosi individuano una sorta di resilienza delle comunità: nel corso di calamità e disastri che investono porzioni rilevanti di territori e di popolazioni, come terremoti, alluvioni, un bombardamento etc., è assai frequente che parte dei sopravissuti locali riesca a mantenere la calma e ad organizzarsi per prestare aiuto a chi invece si trova in grave difficoltà. La salute si raggiunge allorché gli individui sviluppano e mobilitano al meglio le proprie risorse in modo da soddisfare prerogative sia personali (fisiche e mentali), sia esterne (sociali e materiali): "nell'ambito della promozione della salute, salute e malattia non vengono considerate come stati alterni ed esclusivi, bensì come punti terminali ponderati di un flo conduttore comune(contiuità salute e malattia) " (Franzkowiak e Lehmann, 1999). In tale ottica, non si parla più quindi di stabilire se una persona è sana o malata, bensì in che misura essa si allontana o si avvicina ai punti estremi di salute e di malattia. Secondo il modello biopsicosociale, la salute deriva da una combinazione dinamica di aspetti biologici e comportamentali determinata da molti fattori. Essa dipende da una serie di decisioni personali e sociali sulle quali ciascun individuo ha potenzialmente notevole controllo; il modello accentua quindi come alcuni aspetti della salute possano essere controllati dagli esseri umani e come le scelte personali siano importanti determinanti di salute e longevità. La capacità delle persone di identificare e preferire stili di vita benefici e tollerare le tensioni che quotidianamente si trovano ad affrontare dipende soprattutto dalla loro solidità psicologica e interpersonale. Comprendiamo quindi come la resilienza, e costrutti ad essa affini, quali competenze di coping, autoefficacia, hardiness, autostima, capacità comunicative e di risoluzione dei problemi, abbiano un peso rilevante nella promozione della salute. Proprio la relazione tra salute e fattori psicologici rappresenta una componente fondamentale del paradigma biopsicosociale. Le applicazioni sul campo del costrutto di resilienza riguardano: a)la presa in carico e cura, individuale o di gruppo (famiglie, gruppi, comunità) e in differenti ambiti e contesti (scuola, ospedale, servizi del territorio), di chi vive in condizioni e situazioni difficili a causa di eventi dolorosi e complessi da gestire; b)la prevenzione e promozione della salute intesa come un'interazione complessa fra condizioni fisiche e fattori contestuali (ambientali e personali).
Il modello della resilienza interseca molteplici campi, saperi e discipline delle scienze umane, proponendo un approccio multifattoriale e interdisciplinare, che riconosce le competenze specifiche pur uscendo da una logica settoriale e tecnicista. Gli ambiti all'interno dei quali si situa il lavoro dei ricercatori e dei professionisti possono essere suddivisi in: Resilienza congiunturale (connessa a una crisi sfavorevole e ad avvenimenti improvvisi e destabilizzanti): condizioni e situazioni collegate a guerra e/o catastrofi naturali (eventi traumatici, insorgenza di disabilità, maltrattamenti, torture, abusi, povertà, abbandono, assenza, distruzione parziale o totale dei legami sociali di riferimento); Resilienza congiunturale e strutturale: condizioni e situazioni collegate alla presenza di deficit congeniti o acquisiti (correlazioni tra salute e malattia- defcit e processi di apprendimento, conoscenze e sviluppo);
Resilienza strutturale: legata a situazioni sfavorevoli o a stress cronici; condizioni e situazioni di povertà, abbandono, maltrattamento, deficit, disabilità. Gli ambiti di studio vengono poi considerati relativamente ad alcune dimensioni: individuale (ontosistema); familiare/gruppale(microsistema); comunità (ecosistema); collettività/società(macrosistema). Tali dimensioni richiamano il modello ecologico sviluppatosi a partire dalla prospettiva teorica proposta da Brofenbrenner (1996).
Cyrulnik (1998) sostiene che la nozione di resilienza permette di armonizzare diverse discipline (psichiatria, pedagogia, psicologia, sociologia etc.). Uno scopo di tale approccio è quello di determinare una sintesi i cui risultati convergano verso fattori di protezione, e ad integrazione dell'approccio più classico centrato sui fattori di rischio nella presa in carico della vulnerabilità delle persone. Accrescere la resilienza è un percorso personale ed altamente individuale; un approccio che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Occorre inoltre ricordare che le persone usano varie strategie anche come riflesso di differenze culturali. Alcuni autori (Cohler 1995; Gilligan 1997;De Tychey 2001) hanno individuato alcune caratteristiche azioni e modalità relazionali che possono costituire la base per un comportamento resiliente. Come si noteri è proprio sull'acquisizione/rinforzo di tali atteggiamenti, comportamenti, modalità relazionali e soprattutto "rappresentazione di Sé e degli altri" che si fonda il processo di riabilitazione psichiatrica, processo i cui obiettivi, aspettative ed esiti finali sono ovviamente commisurati alla valutazione di vincoli/risorse, alla patologia di ogni singolo soggetto.
Più in dettaglio, gli studiosi considerano fondamentali i seguenti punti:
Creare rapporti: buone relazioni con i familiari più prossimi, con gli amici, o con gli altri, sono importanti. Accettare aiuto e sostegno da chi è interessato e ascolta rafforza la resilienza. Alcune persone trovano che essere attivi in gruppi civici, organizzazioni religiose, o altri gruppi locali fornisca supporto sociale che può aiutare a recuperare speranza. Assistere gli altri nel momento del bisogno può beneficiare anche chi aiuta.
Evitare di vedere le crisi come problemi insormontabili: non si può cambiare il fatto che eventi altamente stressanti succedano, ma è possibile cambiare come interpretarli e rispondere agli stessi. Occorre provare a guardare oltre al presente, e riconcepire come le circostanze future possono essere un migliori. E' indispensabile porre attenzione a qualsiasi esile possibilità di stare un pò meglio, quando si ha a che fare con situazioni difficoltose.

null
La funzione di Resilienza nella Cura (2/2)
A. Piazzn, V. Tullio, S. Oteri, M. Russo
-
Accettare il fatto che il cambiamento è parte della vita: certi obiettivi possono non essere più conseguibili per effetto di circostanze avverse. Accettare le situazioni che non possono essere modificate può aiutare a focalizzarsi su quelle che possono essere cambiate.
Muoversi verso i propri obiettivi: è necessario sviluppare obiettivi realistici; fare qualcosa regolarmente, anche se sembra una realizzazione piccola, che permetta di muoversi verso i propri obiettivi. Invece di focalizzarsi sui compiti che sembrano irrealizzabili, occorre domandarsi "Che cosa posso compiere oggi che mi aiuti a muovermi nella direzione in cui voglio andare?".
Compiere azioni decise: nelle situazioni avverse, per quanto possibile, agire. Compiere azioni decise, piuttosto che staccarsi completamente dai problemi e dalle fonti di stress e desiderare soltanto che scompaiano.
Cercare opportunità per imparare: le persone spesso imparano qualcosa su se stesse e osservano come, per certi aspetti, nella lotta con la perdita sono cresciute. Molte persone che hanno avuto esperienze tragiche ed avversità, hanno conseguito miglioramenti nelle relazioni, un più ampio senso di forza personale anche in momenti di vulnerabilità, un incremento di autostima, una più sviluppata spiritualità, e un maggiore apprezzamento per la vita.
Nutrire una visione positiva di se stessi: accrescere la fiducia nella capacità di risolvere problemi e fidarsi dell'aiuto del proprio istinto sviluppa resilienza.
Mantenere le cose in prospettiva: anche quando si fa fronte a eventi molto dolorosi, provare a considerare le situazioni stressanti in un più ampio contesto e mantenere una prospettiva di lungo periodo. Evitare di gonfiare oltre misura gli eventi.
Mantenere una visione fiduciosa: una visione ottimistica permette di aspettarsi che nella propria vita succedano buone cose. Provare a visualizzare quello che si desidera, piuttosto che preoccuparsi di quello che si teme.
Prendersi cura di se stessi: prestare attenzione ai propri bisogni ed ai propri sentimenti. Impegnarsi in attività che piacciono e che si trovano rilassanti. Esercitarsi regolarmente. Prendersi cura di se stessi aiuta a mantenere la mente e il corpo pronti per affrontare le situazioni che richiedono resilienza.
Imparare dal proprio passato: focalizzare le passate esperienze e fonti di forza personale può aiutare a capire quali strategie potrebbero funzionare per accrescere la resilienza.
La chiave è individuare i modi più adatti e che funzionano meglio, nell'ambito della propria personale strategia per favorire la resilienza. Una di queste strategie è legata all' importanza del senso dell'umorismo nelle situazioni difficili. Già Freud, nel 1905, sottolineava l'importanza del motto di spirito e individuava nella sua realizzazione le medesime dinamiche sottostanti la formazione dei sogni; nella prospettiva psicodinamica, l'umorismo è considerato un meccanismo di difesa altamente maturo e adattivo. "Quando si è poveri, l'umorismo e l'audacia aiutano a reggersi in piedi" scrive Tim Guénard (1995). Molti medici confermano l'importanza dell'umorismo e del riso come fattori di resilienza, basandosi sulla loro esperienza professionale. Gli educatori, gli psicologi ed altri professionisti dell'infanzia che lavorano in situazioni, culture, paesi molto diversi tra loro testimoniano frequentemente l'importanza dell'umorismo nelle situazioni difficili. Il costrutto di resilienza non è da considerare soltanto in riferimento al paziente/utente/destinatario di un qualsivoglia intervento sanitario, ma anche in riferimento all'operatore sanitario affinché quest'ultimo possa cogliere in modo incondizionato il paziente nella complessità, con i suoi interessi, le sue risorse, le sue abilità, oltre che le sue paure e le sue inabilità; non trascurando, ma mettendo tra parentesi ii "ruolo" di ammalato dell'utente e la diagnosi attribuitagli, e partendo dal presupposto che in ogni persona è possibile scoprire una ricchezza interiore fatta di abilità inespresse e di sentimenti, oltre che di un potenziale di crescita che va ben oltre ciò che emerge nel processo riabilitativo. L'operatore, inoltre, deve imparare ad accettare di mettere in gioco il proprio ruolo di datore, ponendosi nella posizione di chi può anche ricevere - e non solo dare - indicazioni, informazioni e nuove abilità e competenze (La Barbera D., et a11.,2007).
L'importanza di un'adeguata formazione di coloro che operano in campo sanitario è, dunque, evidente, ed è legata al bisogno di offrire agli utenti e alle loro famiglie un trattamento efficace ed aggiornato. Una particolare attenzione dev'essere poi rivolta alle barriere emotive, alle difese messe in atto dagli operatori per gestire i difficili, vissuti evocati e sperimentati dalla e nella relazione con i pazienti piu "difficili o particolari"; anch'essi, qualora non attentamente analizzati ed elaborati diventano ostacoli alla costruzione di una relazione partnership con gli utenti. Minkoff (1987)afferma che le barriere emotive sono strettamente dipendenti dal modo in cui gli operatori hanno elaborato i propri lutti e dal modo in cui si pongono rispetto alla prospettiva esistenziale. Da numerose testimonianze, anche gli utenti affermano di essersi sentiti scoraggiati e senza speranza quando entrano in contatto con gli operatori. Deegan (1990) ha chiamato questo fenomeno "rottura di spirito" (spirit breakng), indicando una condizione soggettiva che è il risultato di ripetute esperienze in cui si è stati umiliati, in cui la volontà di vivere è stata profondamente scossa e incrinata, in cui le speranze sono state frantumate, in cui si cerca di proteggere le ultime vestigia di un sé danneggiato. Pertanto, la consapevolezza dei propri limiti emotivi, riuscire a ridurli e a superarli diventa di cruciale importanza, avendo chiaro che tale consapevolezza si raggiunge soltanto con un percorso formativo, con supervisione continua e anche, se è necessario, con il sostegno di una psicoterapia personale. I programmi formativi dovrebbero enfatizzare gli aspetti gratificanti di questo lavoro, ed in particolare del lavoro con le categorie di utenti più complesse da gestire (ad esempio malati psichiatrici, malati terminali, anziani portatori di demenza etc.) ma soprattutto l'elaborazione dei propri vissuti riguardo ai temi del fallimento, dell'onnipotenza/impotenza, della morte etc. È stato dimostrato che le persone realmente capaci di gestire ed utilizzare le proprie risorse affettive, la propria intelligenza emotiva, sono quelle in grado di considerare tale esperienza come parte della loro stessa evoluzione, di entrare in contatto con i propri sentimenti, positivi o negativi che siano, di non temere di immedesimarsi con l'altro e di riuscire a trovare dentro se stessi le risorse indispensabili per contrastare la perdita di speranza che connota alcuni pazienti e le loro famiglie, mantenendo sempre una prospettiva fiduciosa anche in presenza della più acuta disperazione. In tal modo, il coinvolgimento personale diventa un prezioso strumento di lavoro e una fonte di crescita e arricchimento ma per tutte le figure chiamate quotidianamente ad operare nell'ambito della relazione d'aiuto. Non si può aiutare un paziente a costruire resilienza se l'operatore disconosce in sé le proprie aree di fragilità e se non riconosce nell'altro l'esistenza di un'area risanatrice. Anche il rapporto guaritore-ferito è, infatti, un rapporto archetipico, cioè una forma di comportamento potenzialmente innato nell'uomo. In tale particolare relazione si attiva infatti l'artchetipo del guaritore/ferito; ambedue le polarità di questo archetipo sono presenti all' interno dello stesso individuo, in entrambi gli attori della relazione: l'operatore e il paziente. Come per ogni archetipo, se in tale relazione una polarità si costella nel mondo esterno, si costellerà, nel mondo interno, anche quella di segno opposto. Non dunque un particolare archetipo del "guaritore" o del "pazienle" , ma due aspetti dello stesso archetipo. Quando una persona si ammala, viene costellato l'archetipo guaritore-paziente; il malato cerca il guaritore esterno, ma nello stesso tempo si attiva anche il guaritore intrapsichico a cui spesso facciamo riferimento con l'espressione "fattore di guarigione" . Nessuna ferita può rimarginarsi e nessuna malattia può risolversi senza l'azione curativa del guaritore interno. L'immagine mitologica del guaritore ferito è molto diffusa e, da un punto di vista psicologico, ciò significa non solo che il paziente ha un medico dentro di sé, ma anche che nel medico esiste un paziente. La tensione delle polarità non può essere sopportata facilmente dalla mente umana che ama la chiarezza e tenta di eliminarne l'ambivalenza interiore. Ciò può comportare una scissione degli archetipi, in cui uno dei poli può essere represso e continuare a operare nell'inconscio, causando eventualmente dei disturbi psichici. La parte repressa può essere proiettata nel mondo esterno, ciò può dare una momentanea soddisfazione, ma alla lunga significa che il processo psichico è bloccato. La riunificazione con l'aspetto "mancante" delle polarità rischia allora di avvenire pet mezzo del potere. Il medico può trasformare il paziente in oggetto del proprio desiderio di potere. Il suo potere, però, non è forza, ma piuttosto sintomo di fallimento psicologico. Il paziente può fare esattamente la stessa cosa, in modo contrario riconoscendo il potere oppure con la sua sottomissione o con la dipendenza infantile. Il permanere in questa fase comporterebbe rendere il portatore del sintomo eterno paziente ed il terapeuta chiuso alla conoscenza di Sé ed alla sua capacità di poter costellare il fattore di guarigione nel paziente. L'immagine del guaritore ferito simbolizza una coscienza acuta e dolorosa della malattia in quanto polo opposto della salute del medico, la certezza durevole e sofferta della degenerazione del suo corpo e della sua mente. L'operare del curante sarà creativo solo se tiene ben presente che, nonostante la sue cognizioni e la sua tecnica, il suo compito è soprattutto quello di cercare di faciiitare il costellarsi nel paziente del "suo" fattore guarigione. Ma perché ciò accada, dovrà attivarsi un reale processo di resilienza, col travaglio che lo accompagna.

null
ll paziente psichiatrico in Arteterapia (1/2)
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella
-
Con arteterapia si fa riferimento all'utilizzo di una tecnica psicologica di trattamento per i disturbi psichici implicante contesti sensoriali e percettivi che permettono una comunicazione senza l'uso della parola. "L'Arte Psicoterapica" prevede, a differenza della semplice Arte terapia(che si riduce ad una risoluzione catartica d'oggetti psichici repressi o rimossi), l'elaborazione verbale e la presa di coscienza di contenuti inconsci oggetto di rimozione attraverso la liberazione agita d'oggetti latenti. L'uso sempre piu incisivo delle artiterapie in ambito terapeutico sembra sottolineare l'esigenza, da parte della psichiatria, di rintracciare visioni interventive innovative e più funzionali per far fronte alla patologia psichiatrica, nella prospettiva di attivare ulteriori occasioni e nuovi luoghi in grado di meglio gestire quello che la Carozza definisce "una compagnia di vita scomoda e inquietante" (Carozza,2003),ovvero la sofferenza mentale. Il presente lavoro scaturisce dal confronto tra diverse realtà comunitarie riabilitative, presenti nel territorio siciliano, all' interno delle quali viene praticata l'applicazione delle artiterapie in ambito psichiatrico. Tutte le attività con finalità artiterapiche portate avanti nelle suddette strutture non richiedono uno sforzo cognitivo, ma sensoriale e motorio, stimolando contemporaneamente creatività personale, scambio interpersonale ed appartenenza transpersonale. La comunità scientifica è concorde nel concepire la creatività personale, come quel processo creativo posseduto da ogni essere umano che consente di recuperare le relazioni interne ed esterne e di esprimere la propria individualità; lo scambio interpersonale come un processo implicante il riconoscimento vs accettazione dei modeili emozionali altrui, favorendo la socialità; infine, l'appartenenza transpersonale come quella condivisione dell'esperienza umana che scaturisce da una rete di relazioni, presenti nel gruppo. L'utilizzo del corpo all'interno dei laboratori, inoltre, attiva quello che Napolitani (1987) ha definito processo simbolopoietico, che fa riferimento al mettere insieme le cose del mondo secondo un significato proprio dell' individuo. I laboratori esperenziali utilizzano così, come principale mezzo, l'espressione artistica, per favorire la cura e l'innalzamento della qualità della vita. In particolare, il disegno e la pittura, attraverso il ricorso alla fantasia, permettono di contattare il mondo delle emozioni; la danza facilita da una parte il contatto fisico con il gruppo, d'altra parte permette di migliorare il tono muscolare e la coordinazione motoria; la musica favorisce il benessere non solo fisico, ma anche mentale, inoltre grazie al suo valore evocativo modifica lo stato di coscienza, consentendo una regressione del quadro clinico; il teatro, attraverso l'assunzione del ruolo degli attori, crea un clima emotivo che facilita la liberazione dei conflitti; a tal proposito, Moreno scrive che il teatro è ll "posto dove, giocando, si esamina la vita nella sua forma e nella debolezza" (Moreno, 1946).
La finalità comune ai diversi laboratori monitorati era l'attivazione di uno spazio fisico e mentale comune, che permettesse di leggere la realtà in termini di "qui e ora" e di riguardarsi con occhi differenti rifondando nuove modalità di percepirsi e percepire l'altro. In tali realtà territoriali l'arteterapia psicoterapica sembra, alla luce delle osservazioni effettuate, assumere delle caratteristiche del tutto peculiari, divenendo una modalità privilegiata per esplorare la realtà, per comunicare vissuti ed esperienze che, altrimenti, potrebbero rimanere inespressi ed inascolatati. L'iter progettuale ha previsto il monitoraggio attraverso l'osservazione partecipante delle evidenze cliniche ed "artistiche", ovvero dei processi psicodinamici e dei relativi manufatti artistici realizzati dai pazienii. Il monitoraggio è avvenuto mediante la registrazione in itinere ed a posteriori dei contenuti e dei processi emergenti nei differenti laboratori; la conclivisione, ii confronto e la supervisione di tali resoconti, la produzione di foto amatoriali di tutti i prodotti come memoria storica dei gruppi esperenziali, i colloqui clinici retrospettivi. Attraverso i laboratori esperenziali osservati, condotti in prevalenza in setting gruppali, emerge un quadro significativo: i pazienti sembrano avere la possibilità di incanalare il forte investimento affettivo connesso con le aree di sofferenza di cui sono portatori, in un prodotto/processo artistico. Siffatti laboratori sembrano così attivare inedite connessioni comunicative, fondate su livelli di linguaggio e forme espressive differenti, "non indirizzate", quali quello musicale, artistico, teatrale e manuale. Le attività artistiche, restituendo il ruolo attivo al paziente psichiatrico, per troppo tempo destituiti della propria soggettività, all'interno del piu complesso processo di presa in cura, sembrano, inoltre, favorire una risignificazione della loro quotidianità, stimolando il rafforzamento del senso di autostima ed il recupero di un'immagine piu positiva di sé. Come anche la letteratura segnala, un gruppo di psicoarteterapia diviene così "attivo: produce, crea, inventa e gioca in una costante relazione tra l'essere e il fare" (Vazzano, 2004). L'essenza del setting gruppale, nei laboratori di arteterapia, non è rappresentata semplicemente dal porsi del gruppo come un contesto emotivo che rinsalda la fiducia del paziente e aumenta le sue sicurezze, ma anche dall'assolvere la funzione di contenimento delle crisi e delle incertezze, favorendo il contatto con l'ambiente oggettivo, rappresentato dal gruppo stesso e dalla socialità in genere. In tali laboratori la patologia non viene né rimossa né minimizzata, ma accolta come espressione dell'inconscio e in quanto tale rimanda ai significati archetipici pirì profondi. Le attività artistiche esperite in setting gruppali riproducono, così, un microcontesto sociale (Carozza, 2003), in cui ciascun soggetto sviluppa l'assunzione di responsabilità che consentono di acquisire molteplici competenze. Cio che conta non è tanto il valore estetico delle creazioni dei pazienti, quanto piuttosto l'aver preso parte ad un'attività che stimola i rapporti sociali, la collaborazione, l'elaborazione dei conflitti, il confronto, il gioco. Ed è proprio l'aspetto apparentemente giocoso delle attività proposte che assume un'importanza fondamentale.

null
ll paziente psichiatrico in Arteterapia (2/2)
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella
-
Secondo Bion (1962) la dimensione ludica consente di far emergere le parti scisse del paziente, ma costituisce anche la barriera di contatto tra conscio e inconscio, luogo di confine dove nascono i pensieri, i significati, lo spazio e il tempo. "Il gioco è il modo di pensare attraverso immagini non solo evocate nella mente, ma presentificate attratterso la mimica, la gestualità e la struttura temporale, e corrisponde all'attitudine conoscitiva, esplorativa e trasformativa tipica dell'uomo, che si esplica nell'interazione con l'ambiente" (Zanasi, Pezzarossa, 1999).La caratteristica di semirealtà del gioco fa sì che il soggetto riorganizzi la sua esperienza in funzione del gruppo, che dà voce così anche ai vissuti individuali. Dunque le attività psico-artiterapiche non solo sembrano consentire la rielaborazione dei propri vissuti, ma permettono di acquisire quelle categorie (spazio, tempo, significati...) che consentono di rimanere ancorati al proprio presente e di sviluppare un adeguato senso di realtà, all'interno di una nuova nascente lenta progettualità. Sebbene il quadro generale studiato offra questo panorama ottimistico, bisogna sottolineare come la situazione non sia sempre così rosea. Spesso, infatti, la collaborazione all'interno di una comunità è difficile da raggiungere, non solo perché ciascun ospite proviene da un ambiente familiare e sociale totalmente differente, ma anche perché ciascuno è portatore della propria patologia, la cui sintomatologia può risultare disturbante nei confronti degli altri membri del gruppo. Così la creatività non sempre riesce a fungere da elemento unificante, sebbene essa animi il gruppo stesso e consenta, in linea di massima, ad ogni paziente di adattarsi alle restrizioni imposte dal disturbo patologico ed, al tempo stesso, di ripotenziare le proprie doti e capacità personali. Dunque le differenti esperienze messe a confronto, spingono anche a riflettere su un aspetto inquietante della creatività, che vede impegnata la comunità scientifica da diversi decenni: l'ombra della psicoarteterapia. In molti casi si registra, infatti, una tendenza a spingere impositivamente verso la creatività dei pazienti. Un così peculiare modello interventivo può potenzialmente schiacciare e/o esaltare il paziente psichiatrico che, pressato dalla richiesta di espressione di una presunta geniale creatività, può rintracciare nell'atto "creativo" il mezzo per ottenere le attenzioni dei riabilitatori. Bisognerebbe invitare i riabilitalori, parafrasando Ancona (Ancona, 2004), ad una riabilitazione ed una rieducazione del paziente psichiatrico che passi anche attraverso la tolleranza dell'insignificanza, poichè infondere il "furore creativo" nel paziente rischia sovente di diventare la reificazione di un atto onnipotente del riabilitatore, una proiezione delle sue parti narcisistiche. Ogni percorso riabilitativo dovrebbe presupporre un incessante ascolto e revisione psicodinamica dei vissuti dei soggetti coinvolti (operatori e pazienti) e del gioco di proiezioni reciproco, tenendo in debita considerazione l'importanza dell'atto creativo, sottolineata anche da ]ung, per il quale il registro simbolico consente di elaborare le immagini interne, compresi gli archetipi. Così attraverso la fantasia, l'immaginazione, le concrete attività di gioco, disegno, pittura, è possibile dare forma e rilievo alle rappresentazioni che emergono dall' inconscio. Si potrebbe affermare che l 'espressione artistica, musicale, ludica, consenta di avviare un vero e proprio processo di individuazione, mediante il quale il paziente sperimenta il suo senso di identità.
Quanto sopra scritto ci induce a ritenere che un laboratorio gruppale che vanti pretese riabilitative dovrebbe essere concepito come uno spazio di condivisione, esente da massificanti pretese creative, un tassello del percorso riabilitativo dei pazienti in cui si incontrano istanze psicologiche collettive ed individuali, dove poter sperimentare Se, come ci ricordava Jung, "la singolarità dell'indiuiduo va intesa come un'irripetibile combinazione di funzioni e facoltà che in sé e per sé sono universali" (Jung, 7928), la riabilitazione si trasforma in un progetto di vita. La cura diventa un mezzo per vivere la propria normalità, ma anche per avviare <<un'attività e creativa relazione dell'uomo con se stesso e con i suoi simili>> (Fromm,1980). I laboratori diventano così il luogo della libertà, dell'immaginario, in cui ciascuno può elaborare le proprie contraddizioni e i propri conflitti, a partire dai quali ci si può affacciare al mondo esterno, nuove consapevolezze dischiudendo nuove possibilità esistenziali.

null
Comunicare "cattive notizie" in oncologia
Piazza, M. Russo, S. Oteri, G. Vella
-
La presente relazione scaturisce dalla riflessione trasversale su una serie di ricerche/intervento condotte in numerose strutture ospedaliere, sparse su tutto il mezzogiorno, che segnalano la necessaria promozione di un agire delle equipe curanti in oncologia più affettivizzato, in grado di cogliere ed anticipare vissuti e bisogni psicologici, accostandosi al paziente attraverso un canale empatico capace di favorire quell'alleanza di lavoro necessaria per stimolare il processo di autoguarigione; in effetti sembra ormai rappresentare un assunto condiviso dalla comunità scientifica il riconoscimento della capacità comunicativa degli operatori della salute con il malato oncologico come un "momento strategico" dell'assistenza. Il modello d'intervento privilegiato partiva dall'ipotesi che l'apertura al fornire esaurienti informazioni e spiegazioni al paziente costituirebbe un fattore terapeutico, poichè rimanda al paziente la sensazione di una presenza reale e di un autentico intento terapeutico, in cui la disponibilità emozionale appare fondamentale. Alla luce delle testimonianze raccolte e delle osservazioni effettuate, ci sembra di poter affermare come una sensibilità psicologica nella gestione della cattiva notizia oncologica risulti ancora carente, mostrandoci operatori della salute spesso difensivamente sordi al bisogno del paziente di essere sostenuto nel travagliato processo di elaborazione della diagnosi e dei vissuti connessi alla malattia, per riuscire a raggiungere un più funzionale adattamento alla condizione attuale e alle terapie future.
Gli obiettivi perseguiti, nei differenti interventi, sono stati l'esplorazione delle rappresentazioni del processo di presa in carico del paziente al momento della comunicazione della diagnosi oncologica posseduta dal personale medico e l'ampliamento della conoscenza sui vissuti e le risposte emotive dei pazienti e dei loro familiari al momento dell'acquisizione della diagnosi, mentre la finalità era quella di poter pervenire alla formulazione di modelli comunicativi della cattiva notizia oncologica più funzionali al processo di presa in cura del paziente nella sua totalità. I soggetti coinvolti sono stati: personale medico, psicologi, operatori, pazienti e familiari afferenti alle strutture coinvolte. Gli strumenti utilizzati sono stati colloqui, interviste semistrutturate e osservazioni cliniche, i cui dati sono stati letti tramite griglie qualitative costruite all'occorrenza e i più comuni indici di statistica descrittiva. Tra le ricadute operative segnaliamo i percorsi formativi realizzati con un numero ristretto di membri del personale medico coinvolto, finalizzati all'acquisizione di una maggiore consapevolezza delle dimensioni psicodinamiche sottostanti e sostanzianti il proprio agire medico ed il proprio saper essere medico in momenti cruciali come quello della comunicazione della diagnosi, e dei principali meccanismi di difesa e stili relazionali inconsapevolmente agiti nella relazione con i pazienti e con i familiari. Gli oncologi ed il personale medico partecipanti alla ricerca-intervento hanno trovato nella dimensione formativa di questo tipo di indagini uno spazio di confronto con sé e con l'altro da sé, il collega, il paziente, il familiare, la malattia, e con la propria "ombra", attivando un processo di maggiore consapevolezza all'interno del quale poter concepire il momento della comunicazione della cattiva notizia non come meta diagnostica ma come un momento dinamico, come una fase delicata di un work in progress in cui il paziente viene preso in carico nella sua totalità, complessità, soggettività tramite l'ascolto delle proprie risonanze interne. Il dialogo con la propria dimensione emotivo-affettiva può essere utilizzato come antenna ricettiva per la sintonizzazione affettiva con il pazienie, con quanto sia pronto ed in grado di sapere, con quanto è piu utile comunicare nella prima fase della comunicazione della cattiva notizia e quanto sia più utile procrastinare nelle cinque fasi successive, più avanti indicate. E' infatti necessario tenere conto che sei sono le fasi in cui la comunicazione della cattiva notizia oncologica spesso si differenzia, fasi la cui elencazione in un quadro sinottico ha finalità meramente descrittive e che nella realtà fanno parte di un più complesso processo la cui durata varia (o dovrebbe variare) da caso a caso, sia per la risposta soggettiva e per la personalità del paziente che per il tipo di patologia diagnosticata:
1. La prima comunicazione della diagnosi
2. La comunicazione del piano terapeutico iniziale
3. La comunicazione nella "off terapy"
4. La comunicazione nella prima recidiva della malattia
5. La comunicazione nell'inizio della fase terminale
6. La comunicazione con i familiari nella fase del lutto
Gli operatori della salute coinvolti, stimolati a riflettere su come la "cattiva notizia" diventi tanto più inaccettabile quanto più grande è lo scarto tra la percezione della realtà del malato (realtà soggettiva) e la situazione reale (realtà oggettiva), hanno individuato come obiettivo prioritario del professionista d'aiuto quello di rendere meno traumatico il passaggio tra le due realtà, all'interno di un contenitore emotivo-affettivo adeguato, o per dirla come Winnicott, "sufficientemente buono".
Alla luce di quanto emerso in questo studio, qui sommariamente presentato, ci sembra di dover riflettere sul mandato di cui veniamo investiti e ci autoinvestiamo in quanto psicologi: dovremmmo farci promotori di un agire medico nella comunicazione diagnostica più affettivizzato, stimolando nel personale medico ed nel suo staff la capacità di cogliere, vissuti e bisogni psicologici, accostandosi al paziente oncologico mediante la propria sensibilità, la propria intuizione, la propria empatia, garantendo al contempo quella distanza ottimale, quell'astinenza indispensabile al fine di consentire un contatto terapeutico realistico ed una alleanza di lavoro necessaria per stimolare il processo di autoguarigione. Le informazioni esaurienti e le spiegazioni fornite al momento opportuno sono di per sé già un preliminare apporto terapeutico, che rimanda all'ammalato la sensazione di una presenza reale e di un genuino intento terapeutico in cui la disponibilità emozionale appare fondamentale. Il paziente dovrebbe essere aiutato a superare lo shock della diagnosi e ad elaborare i vissuti connessi alla malattia, per riuscire a raggiungere un utile adattamento alla condizione attuale e alle terapie. Il nostro intervento dovrebbe consentire la presa in carico da parte dei curanti anche degli aspetti psicologici del paziente, cercando di favorire la costruzione ed il mantenimento del legame medico-paziente che il sintomo psichico ed un lavoro troppo spesso routinario ed anonimo potrebbero ostacolare, sensibilizzando sul campo il medico ed il personale paramedico. Nonostante la difficoltà di intervento che lo psicologo incontra in un luogo dove è preminente una cultura di tipo medicalistico fondato sull'agire, sarebbe auspicabile un fecondo scambio tra le diverse competenze che garantisca l'assistenza del malato nella sua complessità.
Come sostiene Chiozza (1988), la parte più aspra della nostra professione consiste nel fatto che un uomo malato che cerca una cura è animato dall'idea di "tornare" ad uno stato anteriore, con una forte aspettativa proiettata sul medico di una restituito ad integrum. Ma "la malattia come ogni perdita dell'innocenza è irreversibile e la salute può provenire solo da un 'doloroso progresso' che è completamente opposto alla illusione di tornare". Possiamo riassumere come i tratti salienti del modelio interventivo da noi privilegiato (l'attenzione alle dimensioni emotivo-affettive del paziente oncologico, la capacità di noi operatori di risvegliare le sue <<parti affettive fauste che possano controstare non solo con il cancro ma anche le potenze affettive infauste da esso generate>> (Burrone A., Fornari F., 1999), possano facilitare il processo di cura, e fare in modo che i pazienti possano attingere a <<quei dispositivi innati che ognuno ho dentro di sé che lo spingono a reagire al male col bene. L'incidenza del male stesso può attivare la ricerca del bene e se questa ricerca sarà aiutata da un'adeguata azione psicoproflattica potrà condurre al miracolo di far sì che la gioia alimenti di energie le cellule>> (Burrone A., Fornari F., 1999). Per questo, la formazione psicologica del personale operante in ambito oncologico è un intervento complesso ma necessario. La presa in carico globale del paziente è infatti molto importante in caso di patologie organiche gravi, affinché la persona malata possa usufruire anche di un adeguato sostegno psicologico.

null
Cura psicologica in emergenza: un caso clinico
A. Piazza, M. Russo, V. Tullio, G. Vella
-
In questo lavoro ci soffermiamo sulla resocontazione di un intervento in psicologia dell'emergenza attraverso la narrazione del caso di Veronica, arrivata alla nostra attenzione in seguito ad un incidente stradale che, da vittima primaria di un trauma o vittima che ha subito un danno diretto(Dominici R., 2006), è stata costretta a vivere simultaneamente, o forse prevalentemente, il ruolo di vittima secondaria di un danno indiretto(Dominici R., 2006), avendo contemporaneamente assistito alla morte del fidanzato, alla guida della motocicletta al momento dell'incidente stradale. L'intervento da psicologia dell'emergenza si è gradualmente evoluto in un percorso di sostegno del processo di elaborazione del lutto, guidati dall'ipotesi terapeutica di un processo di elaborazione del lutto concepito come percorso creativo in grado di costellare e dischiudere, una volta superati i penosi momenti paralizzanti della perdita, nuove possibilità trasformative e di emancipazione della personalità. Secondo Verena Kast, infatti, <<il cordoglio è molto di più che sentirsi tristi e addolorati per una perdita; è un processo penoso che, se tollerato, arreca un elemento nuovo alla nostra vita, un quid che non abbiamo mai conosciuto prima. ll processo di sofferenza è in ultima analisi un processo creativo: creativo per quanto concerne la crescita personale>> (Kast V., 1990) . L'evoluzione del caso clinico, dispiegatosi lungo un complesso e travagliato susseguirsi di fasi evolutive, di piccole pause interne e di fisiologici movimenti regressivi, sembra avvalorare questa ipotesi di lavoro. A distanza di circa dieci mesi dall'incidente, l'ipotesi terapeutica è stata confermata: l'elaborazione fisiologica del lutto sembra davvero aver gettato le basi per una effettiva trasformazione della paziente testimoniando la possibilità di una crescita post traumatica.
Il nostro primo incontro, avvenuto nel giorno successivo all'incidente, a meno di ventiquattro ore dall'accaduto, in ospedale, è stato mediato da un'amica di famiglia che, su richiesta dei genitori, anch'essi emotivamente provati per l'accaduto, aveva avviato il contatto telefonicamente. Tenendo conto della singolare domanda, in cui non solo utente e committente non coincidevano ma, i committenti iniziali avevano per "necessità" delegato la richiesta, il primo incontro è avvenuto in ospedale, consapevoli della flessibilità del setting che un tale contesto di emergenza spesso impone. L'intervento precoce (consistente nell'offerta immediata di un sostegno psicologico in fase acuta), in un siffatto contesto di emergenza, legato alla perdita improvvisa del proprio compagno, costituì un fattore terapeutico e di protezione che favorì un fisiologico decorso del processo di elaborazione del lutto ed una prevenzione della cronicizzazione del Disturbo Post Traumatico da Stress. Al momento del nostro primo incontro, Veronica aveva da poco avuto la certezza, apprendendolo dal padre del fidanzato, che il ragazzo fosse morto. La paziente, come esplicitato precedentemente, ha maturato una sua committenza interna quasi immediatamente, mostrandosi fin dall'inizio disponibile e partecipe alla nostra relazione ed al nostro lavoro. Durante i primi incontri in ospedale avevamo esplorato la possibilità di andare a trovare in obitorio il fidanzato defunto, lasciando spazio all'espressione delle paure e del dolore scatenati dalla possibilità di questo ultimo incontro, e ritenendo indispensabile <<imparare ad accettare il dolore, e manifestarlo, e trovare le parole e i silenzi per dare forma umana all' impensabile, allo schianto che ci atterra interiormente>> (Ravasi Bellocchio L., 1992)
Così, su richiesta di Veronica, la paziente è stata accompagnata presso l'obitorio. All' ingresso della camera mortuaria ebbe un crollo emotivo. Rientrata la crisi, Veronica riuscì ad entrare con serenità nella stanza dove giaceva, disteso, il corpo senza vita: lo accarezzò teneramente, depose tra le sue mani la lettera scritta precedentemente e la foto e lo baciò. Quello dato da Veronica al fidanzato, non fu però un addio reale, per il quale, come si leggerà in seguito, bisognerà aspettare diverso tempo, e lasciare che una parte di sé venisse seppellita con lui. Tuttavia, a questo gesto non è da attribuire un significato negativo poiché, grazie ad una sua successiva simbolizzazione, costituì il presupposto per consentire la necessaria morte di alcune parti di sé e la rinascita di altre. La specificità del contesto ospedaliero ha richiesto non di rado numerose interruzioni del nostro dialogo, un dialogo cominciato silenziosamente e delegato naturalmente al nostro primo sguardo, gettando le basi per quell' alleanza terapeutica che presto si sarebbe sviluppata, necessaria per l'evoluzione del nostro percorso, che da iniziale consulenza di sostegno si trasformerà da li a breve in una relazione veramente terapeutica.
La paziente, durante la degenza ospedaliera, manifestò dei tratti di tipo paranoico, fino a sfiorare, come già segnalato, le punte di un delirio in alcuni frangenti significativi, facendo inizialmente supporre che potesse attivarsi una forma paranoicale (Fornari F., 1955)di evoluzione del processo luttuoso. E' stato pertanto necessario offrire intanto un immediato contenimento, rimandando una possibile riflessione su di essi, che successivamente ha consentito una maggiore integrazione di queste parti. Il trasferimento della sede dei nostri incontri ha consentito di neutralizzare le ineliminabili interferenze interne ed esterne emergenti in un setting ospedaliero ed una maggiore esplicitazione e rispetto crel contratto terapeutico.
Al primo incontro in studio, l'aspetto di Veronica, sebbene marcatamente provato dall'accaduto, appariva visibirmente più curato. E' da questo momento in poi che la consulenza psicologica si è gradualmente trasformata in un rapporto terapeutìco, grazie al fatto che Veronica, nonostante la tragicità del momento, sia stata in grado di cogliere l'occasione per poter migliorare la qualità della propria vita con effetti a lungo termine. Sembra necessario fare una precisazione: quando ci riferiamo non ad una meta raggiunta definitivamente da Veronica, ma ad un processo attivato, un work in progress, una <<forma di transizione pschica che comporta la regressione e una contemporanea "perdita del senso dell'Io" al fine di portare alla coscienza e di realizzare un bisogno psicologico fino allora non riconosciuto>> (samuers, 199g). Possiamo affermare che, come in ogni percorso psicoterapeutico, la trasformazione ha comportato un accurato riconoscimento dell'ombra ed incluso la morte simbolica e la rinascita. Si può parlare di una trasformazione relativa, garante della continuità psichica della paziente, poichè, come anche Jung ha osservato, una trasformazione assoluta avrebbe potuto portare ad una scissione della personalità, o comunque ad una condizione patologica. Veronica sembra aver dato ascolto a quell'istinto trasformativo naturale che contraddistingue ogni essere umano, sperimentando la conoscenza di sé come <<via di salvezza, come potenza dello spirito che trova o ricrea l'armonia>> (Donfrancesco 1998). Attualmente siamo nella chiusura di una fase del Percorso psicoterapeutico della paziente, per continuare assieme a lei il viaggio verso l'ampliamento della conoscenza di sé, consapevole con Veronica che <<la morte è la nascita della vita che ancora abbiamo da vivere>> (Woodman M., 1996). Il dialogo terapeutico, una volta elaborato il lutto, sta continuando sempre più consapevolmente, lungo il faticoso processo di differenziazione, catalizzato probabilmente dall'elaborazione dell'evento luttuoso stesso.

null
Arteterapia in psicosi attraverso il disegno
A. Piazza., G. Ajello, G. Giannì, M. Russo
-
L'arteterapia individua i propri elementi costitutivi nel delicato equilibrio tra procedure, tecniche e libertà espressiva, tra la cornice dello scenario, il setting artistico e le dinamiche relazionali sollecitate dal processo creativo (Bedoni G., Tosatti B., 2000). Tale lavoro si propone di esplorare l'ambito delle artiterapie, e in particolare come queste possano essere impiegate con soggetti psicotici che presentano delle difficoltà a livello della comunicazione verbale, ritenendo possibile descrivere l'arteierapia come uno strumento che può favorire lo sviluppo personale attraverso forme alternative di comunicazione. Molto spesso, infatti, i pazienti affetti da malattie psichiatriche esprimono, o cercano di esprimere, i loro disagi attraverso l'utilizzo di forme comunicazionali che travalicano il canale verbale, approdando in molte occasioni, all'uso del disegno, della pittura, della scultura etc...Negli anni, tale ambito è diventato terreno fertile per la strutturazione di metodiche terapeutiche che prendono il nome di arteterapie (includendo in questa macroarea anche la musicoterapia, la danzaterapia e le tecniche psicoterapeutiche vicine all'espressione teatrale). Naturalmente, tali tecniche prescindono dalla qualità dell'opera finale o della messa in scena, puntando l'interesse e l'applicazione sul percorso stesso, che attraversa il soggetto affetto da disagio psichico, nel cercare di esprimere se stesso, i propri conflitti, la propria individualità, grazie a tali forme espressive a metà strada tra il "curativo" e l'artistico. I binomi "genio e sregolatezza" ,"arte e follia", hanno, infatti, spesso accompagnato le vite di molti artisti (e di molti pazienti psichiatrici), stimolando l'attenzione di Psicologi, Psichiatrici e studiosi del fenomeno. Già Lombroso , nel famoso saggio "Genio e follia" (1864), sosteneva che la follia fosse in grado di potenziare le abilità creative dell'individuo: il soggetto, liberandosi dalle difese razionali che non gli permetterebbero di realizzare comportamenti o esperienze apparentemente irragionevoli o assurdi, lascia libero il freno della fantasia ed è in grado di produrre creazioni nuove ed originali (Lombroso C.,1864). Nel corso degli anni, l'arteterapia si è andata sviluppando progressivamente, generando anche un codice di specificità che ne accerta la validità e l'eticità. Le discriminanti che ci permettono di distinguere le esperienze artiterapeutiche sono la formazione dell'operatore, che deve essere clinica e deve basarsi su basi artistiche professionali e semi-professionali; il contratto, per cui l'utente deve essere informato e consapevole del percorso arteterapeutico; l'agire entro un'istituzione o, in caso di aree private, di concerto con il progetto complessivo di cura; la presenza di un'équipe multidisciplinare che appoggi e verifichi il trattamento; l'esigenza di un modello di riferimento a cui riferirsi; la supervisione.
La finalità dello studio resocontato in questo lavoro è stata quella di esplorare, da un punto di vista psicodinamico, come l'arteterapia possa essere, per i pazienti in cura presso le C.T.A., un esercizio utile a stimolare la comunicazione di vissuti ed esperienze che, altrimenti, potrebbero rimanere inespressi.
Vari studi (Ortoleva R., Testa F.,2003 ) hanno messo in evidenza come l'arteterapia ricorra ad un codice linguistico diverso rispetto alla parola, e pertanto "linee, forme e colori possono effettivamente rappresentare un punto di fuga che interrompe il circuito vizioso del sintomo: (...) incoraggiando una positiva immagine di sé, (...) e fornire un'esperienza che apre nuove prospettive anche sul piano di un'elaborazione verbale" (Trivelli C.P., Taverna A., 2000). Tra l'atro, l'esperienza arteterapeutica, basandosi sul potenziamento delle risorse individuali, sull'utilizzo delle parti "sante" del paziente, si prefigge i seguenti obiettivi: facilitare il potenziamento delle sue abilità interpersonali, favorire sia l'espressione che il contenimento delle emozioni attraverso la condivisione in gruppo delle proprie esperienze, stimolare le funzioni cognitive e i processi di simbolizzazione, promuovere l'autostima e la fiducia in sé stessi e facilitare la scoperta delle proprie risorse emotive (Trivelli C. P., Tavema A., 2000).
Pertanto abbiamo incontrato un paziente di una C.T.A. siciliana, che ha partecipato al Ìaboratorio artistico svoltosi nella C.T.A. stessa. Nello specifico, il laboratorio, dopo una prima giornata di incontro durante la quale un artista siciliano, oltre a stabilire una relazione empatica fondata sulla fiducia e sulla collaborazione, ha introdotto il percorso che si stava per intraprendere, ci sono stati altri incontri centrati sia sull'espressione personale, attraverso l'uso di carboncini e acrilici, sia sul lavoro di gruppo, in cui tutti i partecipanii erano impegnati nella realizzazione di un progetto comune. Al termine di ogni "seduta" veniva proposto un momento di riflessione gruppale sulle attività svolte, ed anche uno spazio di restituzione offerto sia dall'artista che dalla Psichiatra che monitorava il laboratorio.
E poiché uno dei punti di forza delle artiterapie è dato dal fatto che questa tecnica è particolarmente indicata per quei soggetti che presentano delle difficoltà a livello della comunicazione verbale, lo scopo dell'arteterapeuta è quello di favorire l'espressione del soggetto attraverso il disegno, o altre forme espressive, aiutandolo a sviluppare nuove abilità creative, in grado di agevolare la scoperta di sé, stimolando lo sviluppo personale attraverso forme di comunicazione diverse dalla parola. Sulla base delle riflessioni emerse durante l'incontro con il soggetto, è stato possibile evidenziare come attraverso il disegno, all'interno del percorso arteterapeutico, il soggetto abbia avuto la possibilità di prendere coscienza di aicuni sentimenti. A proposito dell'espressione artistica, il pazienie dice: "è un momento di libera espressione, di comunicazione interiore, che mi permette di esprimere il mio mondo interno, il mio stato d'animo. Il disegno è un momento di libertà interiore". Per concludere, è bene operare una riflessione anche sul fatto che spesso il rischio dell'arteierapia è quello di ridurre il lavoro ad un semplice intrattenimento dei pazienti. Questa metodica di intervento può risultare del tutto inefficace se non c'è adeguata formazione di chi le mette in pratica. Difatti, per definire una terapia artistica l'operatore deve possedere una formazione sia artistica(dovrebbe avere competenze articolate nell'area dell'espressione e delle tecniche artistiche) che psicologica (la preparazione dovrebbe basarsi sulla conoscenza delle dinamiche di gruppo, delle dinamiche relazionali, dei processi psicodinamici, etc.).

null
PRENDERSI CURA DEL MALATO DI ALZHEIMER: RAPPRESENTAZIONI E VISSUTI DEGLI OPERATORI
A.PIAZZA, V. TULLIO, M. RUSSO
Dipartimento di psicologia, Università degli Studi, Palermo
kaivalya@unipa.it
-
Introduzione
In un momento storico e sociale come quello attuale, dominato dalle parole benessere, vita, immortalità, in cui il sistema Medico continua a condurre la propria guerra "personale" contro la morte attraverso la ricerca del modo di rallentare i processi che sono alla base dell'invecchiamento, il progressivo aumento dell'età media della popolazione con il conseguente aumento dell'incidenza di malattie come l'Alzheimer sottolinea, paradossalmente, l'impotenza della "potenza medica". Il vissuto di onnipotenza del "potere tecnico", rinviante al paziente l'immagine di un professionista onnisciente e infallibile allo scopo di eludere la fantasmatica della morte è messo a dura prova nell'incontro con la Malattia di Alzheimer, una patologia cronica, degenerativa ad esito infausto, che evoca nel malato, nei caregivers e soprattutto negli operatori sanitari fantasmi e vissuti difficili da gestire. Lavorare con pazienti che soffrono di demenza può suscitare profonde emozioni, perché questa malattia compromette ciò che più caratterizza "l'essere umano": la consapevolezza di se stessi, del tempo, dello spazio, il sentimento di continuità attraverso il tempo, la possibilità di proiettarsi nel futuro. Sono molti e con diverse professionalità gli operatori che lavorano con pazienti affetti da Malattia di Alzheimer negli ambulatori , day hospital, servizi domiciliari etc. Tutti questi operatori si trovano quotidianamente in contatto con persone anziane, con pesanti deficit cognitivi, fisici e funzionali, talora morenti. Già di per sé ciascuna di queste condizioni suscita sentimenti e vissuti, difficili da gestire; nel caso del malato di alzheimer spesso queste condizioni sono tutte contemporaneamente presenti in un solo soggetto. A tutto ciò si deve aggiungere che, di solito, lavorare con questi pazienti significa anche occuparsi dei loro familiari, con ulteriore carico emotivo. Gli operatori che lavorano con pazienti affetti da demenza in generale, e dal morbo di Alzheimer nello specifico, sperimentano spesso sentimenti di tristezza, frustrazione, impotenza e paura di essere, un giorno, vittime della stessa malattia. Talora occorre far fronte a comportamenti difficili, come il vagabondaggio, l'aggressività, le condotte sessuali incongrue, oppure a richieste di assistenza nel nutrimento e nell'igiene personale, che mettono a dura prova la resistenza dell'operatore, la percezione della propria competenza e professionalità, la convinzione che il proprio operato sia utile. Il doversi confrontare con una malattia che, in quanto degenerativa, non dà speranze di guarigione al soggetto che ne è affetto, il confrontarsi con le proprie simbolizzazioni della vecchiaia, della malattia e della morte, o ancora, l'essere genitori, figli, amici, di persone in analoghe condizioni di salute genera e al tempo stesso si scontra con le aspettative di "onnipotenza", di successo generalizzato e immediato che accompagnano quasi sempre le motivazioni, consce e inconsce, degli operatori sanitari.
Metodo
La finalità del lavoro realizzato è stata quella di esplorare le Rappresentazioni relative a Qualità della Vita e Modelli di Cura all'interno dei differenti contesti della Salute. Obiettivo specifico di questo studio è stato esplorare le Rappresentazioni degli Operatori Sanitari sulla Qualità della Vita di Soggetti con Malattia di Alzheimer, a partire dall'ipotesi che le Rappresentazioni di tali Operatori su Qualità della Vita e della Salute orientino l'utilizzo dei modelli di presa in carico dei pazienti e lo stesso processo di cura. Soggetto di questo lavoro è stato l'intero Universo degli Operatori afferenti al Centro Alzheimer sito presso la Cittadella della Salute di Trapani. Gli Strumenti utilizzati per la Rilevazione dati sono stati: 1) Questionario strutturato ad autosomministrazione, per l'esplorazione delle Rappresentazioni degli Operatori relative alle caratteristiche del paziente con Malattia di Alzheimer, alle variabili che incidono maggiormente sulla Qualità della Vita di quest'ultimo e al Modello di Intervento proposto dalla struttra; 2)Intervista; 3) Osservazione. I dati raccolti, sono stati elaborati attraverso l'utilizzo di indici di statistica descrittiva e di griglie per la lettura degli elementi qualitativi.
Risultati
Benché nelle risposte date al Questionario venga affermata, da parte degli Operatori del Centro, una grande attenzione agli aspetti psicologici ed ai vissuti legati alla Malattia di Alzheimer, gli stessi Operatori nel rispondere alle domande aperte del Questionario e durante le interviste si sono centrati quasi esclusivamente su aspetti oggettivi inerenti il lavoro a contatto con questi pazienti; mai hanno fatto riferimento a se stessi, al significato che per loro riveste il fatto di lavorare a contatto con questo tipo di utenza, alla loro eventuale necessità di supporto psicologico. Un qualche nesso potrebbe essere riscontrato/segnalato tra questa incapacità a parlare di sé e le resistenze poste alla compilazione del questionario. Presso il Centro Alzheimer considerato, sembra affiorare, negli operatori, una sorta di scissione tra ciò che si ritiene "razionalmente" importante (ossia il prendersi cura dell'altro, il riconoscimento degli aspetti psicologici e dei vissuti legati alla Malattia di Alzheimer, il "calore" relazionale l'empatia etc.) e la pratica quotidiana (centrata quali esclusivamente sugli aspetti oggettivi ed oggettivizzanti, della malattia, della relazione con il paziente, dell' intervento realizzato); tale scotomizzazione rievoca un distanziamento rigido e meccanizzante nella cura tecnica del contatto empatico con le simbolizzazioni di vita e morte che caricano il prendersi cura di tali pazienti.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto precedentemente, ci sembra che i dati emersi dalla ricerca indichino, quale importante ricaduta operativa, la necessità per gli Operatori di prendere contatto con le dimensioni inconsce e fantasmatiche evocate dal peculiare contesto di cura, di acquisire consapevolezza dei propri vincoli/risorse, anche attraverso la realizzazione di un percorso di formazione psicodinamico teso all'implementazione delle risorse interne degli operatori stessi e che possa consentire a questi ultimi di gestire adeguatamente i propri vissuti.
Riferimenti bibliografici
Alzheimer Italia, Manuale per prendersi cura del malato di Alzheimer,1999.
Cesa-Bianchi M., (a cura di), Psicologia dell'invecchiamento,
Carocci, Roma, 1987.
De Caprio L., La morte della mente ed i limiti della ragione.
Dilemmi etici nella malattia di Alzheimer, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998
De Michelis O:, Psicologia e Alzheimer, L'Artistica Editrice, 2000.
Gabbard G.O., Psichiatria psicodinamica, Raffaello Cortina Editore, Milano,2002.
Genevay B., Katz R.S., (1990), (tr.it.), Emozioni degli operatori nella relazione di aiuto. Controtransfert nel lavoro con gli anziani,
Erikson, Trento, 1994.,
Zucconi A., Howell P., La promozione della salute, Edizioni La Meridiana, Molfetta, 2003.

null
PADRI IN ATTESA. UNA RICERCA SULLA PSICODINAMICA DELLA PATERNITÀ
V. TULLIO, M. RUSSO, C. PRESTIFILIPPO
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi, Palermo
kaivalya@ unipa.it
-
Introduzione
Il presente contributo costituisce la resocontazione di una ricerca empirica, che si inserisce nell'ambito di un più vasto studio sulla psicodinamica della gravidanza realizzato nel territorio agrigentino e palermitano. A partire dall'ipotesi che se l'attesa della gravidanza è vissuta con consapevolezza emozionale da parte dei futuri padri, questa esperienza potrà potenzialmente trasformarsi in una risorsa evolutiva per l'integrazione dell'identità paterna, all' interno del più complesso processo individuativo,la finalità perseguita è stata quella di esplorare, a posteriori, a partire da un vertice psicodinamico, l'immaginario della paternità relativamente al periodo precedente la gravidanza, al periodo gestazionale ed al trimestre successivo alla nascita del figlio. Dai suddetti presupposti, sono scaturiti gli obiettivi perseguiti nel corso della ricerca: l'esplorazione della rappresentazione della paternità nel periodo antecedente l'inizio della gestazione, nel periodo gestazionale e nei tre mesi successivi al parto; l'esplorazione dei vissuti connessi alla relazione di coppia, alla relazione filiale ed al rapporto con se stessi.
Metodo
Per la rilevazione dei dati, sono stati coinvolti nella ricerca 70 soggetti, padri da tre mesi al momento dell' indagine, selezionati mediante adesione spontanea. tramite numerosi cicli di corsi di preparazione al parto; per quanto riguarda gli strumenti, è stato utilizzato un questionario semistrutturato, costruito ad hoc per esplorare le principali aree oggetto d'indagine.
Risultati
I dati sono stati elaborati tramite indici di statistica descrittiva relativamente ai dati quantitativi, e analisi psicodinamica dei temi emersi, per ciò che concerne i dati qualitativi. L'analisi dei risultati ha messo in luce come la gravidanza debba essere ritenuta un evento che vede anche psicodinamicamente coinvolti entrambi i genitori, un'esperienza che, al di là dell'aspetto biologico, è intrisa da forti implicazioni psicologiche per entrambi i patners della coppia. Il padre, per troppo tempo considerato "periferico", oggi non solo sembra essere più presente nella cura dei figli, ma appare "paternamente" anche coinvolto nel processo gestazionale. L'analisi dei risultati sembra confermare l'ipotesi iniziale che se anche gli uomini vivono con consapevolezza emozionale il periodo gestazionale, questa esperienza potrà potenzialmente trasformarsi in una risorsa evolutiva per l'integrazione dell' identità genitoriale, all' interno del più complesso processo individuativo del soggetto, un'esperienza in grado di mediare tra le istanze ctonie e spirituali della psiche che ogni soggetto può assecondare solo opponendosi alle tendenze unilateralizzanti endo ed esopsichiche, che minacciano di neutralizzare la sua spinta propulsiva verso la sua unicità ed autenticità, influenzando l'originale progettualità del suo peculiare modo d'essere nell'ambito di un variegato ventaglio di possibilità bio-psichicamente e socialmente determinato.
Conclusioni
La gravidanza si costella, così, come un processo di compartecipazione psicoaffettiva e corporea riguardante la coppia che, se accolta con consapevolezza da entrambi i genitori, connota positivamente una fase psicoevolutiva importante per lo sviluppo del processo individuativo di entrambi, dischiudendo potenzialmente ulteriori progettualità esistenziali. Il significativo coinvolgimento del padre nell'esperienza dell'attesa del figlio e nella cura del figlio, emerso dalla ricerca, orienta la riflessione, in termini di ricadute operative, sulla necessità di offrire all'interno della società maggiore attenzione ai vissuti della paternità attraverso la realizzazione di "spazi" che consentano ai futuri padri di contattare, elaborare ed esprimere tali dimensioni emozionali. In opposizione ad un orientamento, ancora dominante, di tipo maternocentrico, sarebbe auspicabile pensare, accanto ai corsi di preparazione al parto, a possibili percorsi di accompagnamento alla paternità che non riducano il ruolo del padre ad una mera funzione di sostegno per la donna, ma che si costituiscano come degli spazi, reali ed interiori, di elaborazione della propria esperienza gestazionale. Se, come sosteneva Jung,(1912/1952) i figli sono forieri di una duplice e conflittuale tendenza, propulsiva e regressiva, questi percorsi dovrebbero fungere nel padre da catalizzatori di un processo di consapevolezza sulla immagine interna padre-figlio in lui presente, versus una maggiore propulsione allo sviluppo del Sé, riducendo il rischio di trascinare <<nell'ombra il "paterno", producendone un graduale e apparentemente irreversibile declino con il rischio d'oblio della ricca eredità anche delle più alte specificità mascoline personificate nell'immagine paterna>> (Melodia C.,2002).
Riferimenti bibliografici
Jung C.G. (1912-1952), (trad. it), "simboli della trasformazione", in Opere, Vol. 5, Bollati Boringhieri,
Torino, 1970.
Melodia C. (2001), "Lo Specchio del Barbiere:riflessioni simboliche su "potenza" del paterno e individuazione", in Atti dell'XI Convegno Nazionale CIPA, Vivarium, Milano.
Piazza A., Russo M., Picone L. (2002), "Nascere per non morire.
Una ricerca su psicodinamica della gravidanza, immaginario del parto ed angoscia di morte" in Atti del V Congresso Nazionale di Psicologia della Salute, Università degli Studi di Firenze.
Rossi N., Bassi 1., Delfino M.D. (1993), Atteggiamento psicologico verso la gravidanza ed adattameno emotivo successivo al parto, Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria,53 (3).
Russo M. (2001), "Psicodinamica della Gravidanza: Immaginario del parto e angosce di morte" in Atti del III Congresso Nazionale AIP-
Sezione di psicologia clinica, Edizioni Istituto Carlo Amore, Roma.
Zoja L. (2000), Il gesto di Ettore. Preistoria, Storia, Attualita' e scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, Torino.

null
Il linguaggio tecnicistico e la comunicazione per la salute
Piazza A, Russo M, Prestifilippo C, Schimmenti A, Zaoner L.
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Palermo
-
L'area esplorata dalla ricerca-intervento qui descritta - a partire dall'ipotesi che l'uso di un linguaggio tecnicistico da parte dei diversi operatori delle équipe influenzi la qualità del loro lavoro in quanto dispositivo difensivo ostacolante i processi comunicativi intersoggettivi - è la babele di linguaggi tecnicistici simultaneamente utilizzati nei processi comunicativi intercorrenti tra équipe pluridisciplinari, pazienti e familiari. Secondo gli operatori coinvolti nella ricerca "da elemento di coesione tra gli appartenenti alla stessa caregoria professionale, il linguaggio specialistico si trasforma in distanziatore tra colleghi portatori di un sistema di simboli e segni di diversa estrazione". Il linguaggio tecnicistico, marcando le differenze intersoggettive, sembra costringere gli operatori a un confronto slatentizzante la tensione fra voglia di proteggere la propria identità professionale e opportunità di migliorare nell'incontro con l'alterità. Sono stati coinvolti operatori di differente estrazione professionale operanti all'interno delle AUSL. L'elaborazione dei dati raccolti mediante il colloquio gruppale, i focus group e l'osservazione all'interno delle riunioni periodiche di équipe è stata attuata attraverso griglie qualitative e indici di statistica descrittiva. I risultati costellano un quadro complesso, contraddistinto da una difficoltà a confrontarsi con profèssionalità diverse ed evidenziando un'impermeabilità alle risorse dei colleghi, vissuti come "potenzialmente minacciosi rispetto alla stabilità della propria identità professionale". Alla luce dei dati raccolti, l'uso di un linguaggio eccessivamente tecnico sembra poter esser letto come modalità di affermazione della propria identità nei suoi aspetti più legati all'area dell'efficienza tecnicistica, focalizzata più sul versante dell'informazione e della chiusura che della comunicazione e della condivisione.

null
Il trapianto di midollo osseo tra morte e rinascita dell'identità: un contributo di ricerca
Piazza A, Schimmenti A, Giannì G, Oteri S, Russo M.
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Palermo
-
Il trapianto di midollo osseo costituisce una pratica terapeutica talvolta risolutiva, e quindi di life saving, di fronte a patologie quasi certamente mortali. Tale intervento non esime il soggetto che se ne avvale dal percorrere un complesso processo di accettazione ed elaborazione psicofisica. Il trapianto di midollo, suggerisce Chiesa (1989), impone al soggetto di predisporre uno spazio simbolico all'interno dell' identità psicocorporea nel quale integrare un "intruso" (l'organo) (Ruolo e Poznanski 1999). L'onere psicologico imposto dall'immissione di un organo liquido estraneo che deve "prendere vita" all' interno del corpo per poter "donare la vita" viene gravato dalla sofferenza che il soggetto sperimenta prima e dopo il trapianto. Tale scelta terapeuitca infatti subentra generalmente dopo diagnosi nefaste che assorbono il soggetto in dimensioni mortifere molto difficili da gestire sia sul piano fisico che psichico. La diagnosi di cancro, gli sforzi terapeutici attraverso lunghi e sofferti cicli radio e chemioterapici precedono la consapevolezza del fallimento di questi tentativi. Subentra poi la sofferta ricerca di un donatore consanguineo o estraneo, la speranza alternata allo sconforto, seguiti, laddove sia possibile effettuare il trapianto, da una lunga degenza in camera sterile e un'incerta convalescenza. Dopo il trapianto il dialogo spesso continua per mesi o anni, modificando talvolta definitivamente il benessere intra e interpersonale del paziente e dei familiari. Il contributo che l'équipe curante e le persone care possono offrire, attraverso una comunicazione empatica e contenitiva, è di fondamentale importanza nel travagliato e controverso cammino che il soggetto deve compiere. Le rappresentazioni identitarie e i rapporti inrerpersonali devono subire un processo di elaborazione per poter integrare e rimodulare le trasformazioni imposte dalla malattia.
CHIESA S. Il trapianto d'organo: crisi e adattamento psicologico. Psichiatria e Medicina 1989, n. 10.
RUOLO G, POZNANSKI C. Psicologia e psichiatria del trapianto d'organo.
Masson, Milano 1999.

null
Le rappresentazioni dell'abuso: una ricerca con gli operatori del progetto "Campo Infanzia Serena"
Piazza A*, Schimmenti A* *, Ajello G*, Prestifilippo C*, Russo
M*.
*Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Palermo;
**Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino
-
Gli operatori che si occupano di promozione della salute con bambini maltrattati si confrontano necessariamente con le proprie rappresentazioni mentali sul fenomeno dell'abuso. Nella ricerca abbiamo esplorato tali rappresentazioni negli operatori italiani del progetto itinerante "Campo Infanzia Serena", un'iniziativa di promozione della salute attiva in 9 paesi dell'Unione Europea. L'ipotesi che ha guidato il lavoro è che gli operatori possano aiutare il bambino maltrattato a rielaborare le sue dolorose esperienze, se capaci di attivare un legame empatico di contenimento. Lo strumento utilizzato è un questionario realizzato ad hoc, costituito da 11 domande. I dati sono stati analizzati quantitativamente e qualitativamente . Tra i risultati della ricerca evidenziamo che : a) per gli operatori intervistati l'abuso si fonda sia su variabili di tipo oggettivo (aspetto fisico del bambino, livello culturale della famiglia) che soggettivo (vulnerabilità emozionale del bambino, incapacità di sintonizzazione emotiva dei caregiver); b) l'immagine che l'operatore ha del bambino abusato appare impregnata da valenze emotive destrutturanti, spesso,"agite" attraverso comportamenti riparativi o cristallizzate entro vissuti di impotenza; c) laddove restano sullo sfondo nel bambino maltrattato la paura e la vergogna, sovente vittime di diniego, l'operatore soffre nel confrontarsi con l' immagine idealizzata dell'abusante, che costituisce la fragile "costruzione" del bambino per evitare il "crollo" psichico (Bonomi e Borgogno 2001). L'analisi delle simbolizzazioni reltive all'abuso, secondo la nostra esperienza, può "desaturare " i vissuti problematici e dolorosi con i quali gli operatori si confrontano, ma ci sembra occorra ancora una riflessione più ampia da parte della comunità scientifica su tali ambiti d'intervento.
BONOMI C, BORGOGNO F (a cura di). La catastrofe e i suoi simboli. UTET. Torino 2001.

null
Lo specchio nel tempo: vissuti degli adolescenti sul corpo dei coetanei con handicap e degli anziani
Piazza A, Ajello G, Prestifilippo C, Russo M, Visani V.
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Palermo
-
Il presente lavoro di ricerca si propone di esplorare come l'immaginario degli adolescenti in relazione alla psicocorporietà di coetanei portatori di handicap e di anziani incida nei loro processi di scambio comunicazionale. L'ipotesi è che gli adolescenti guardino all'identità psicocorporea dei loro coetanei disabili e degli anziani attraverso un immaginario saturato dalle loro rappresentazioni dell'handicap e della senilità. La ricerca aveva l'obiettivo di esplorare quali siano le variabili che prevalentemente intervengono nel ritenere che un portatore di handicap o un anziano possano percepirsi a proprio agio nell'esporre il loro corpo in estate. Sono stati coinvolti 100 adolescenti di età compresa tra i 13 e i l8 anni, intervistati attraverso un questionario appositamente costruito. Secondo i soggetti coinvolti, la condizione di sgradevolezza percettiva della "disabilità" viene spesso rinforzata anche dall'ambiente che genera pregiudizi e non permette al soggetto disabile di piacere e di piacersi; pertanto al disabile sembra essere "disconosciuta" la propria adolescenza e il gruppo dei coetanei sembra vivere nei suoi riguardi, a livello inconscio, un certo grado di conflittualità, come se in un gioco di proiezioni dell'ombra il coetaneo con handicap incarnasse le ansie adolescenziali relative all'immagine corporea e a ciò che essa rappresenta. Per quanto concerne l'immaginario adolescenziale sulla psicocorporeità degli anziani, si è riscontrata la tendenza a una rappresentazione "satura" dell'anziano, percepito entro i limiti della dimensione involutiva dell'efficienza fisica o difensivamente "scisso" da una rete di cariche affettivo/relazionali connesse agli aspetti positivi del divenire anziani (per esempio l'essere più consapevoli di se stessi e delle proprie risorse interiori). Poiché l'adolescente è messo in crisi dalle metamorfosi della sua identità psicocorporea non ancora pienamente strutturata) affiora la difficoltà a porsi in dialogo con i propri vissuti interiori rispetto alle trasformazioni psicologiche relative allo psicocorpo dell'anziano, difensivamente percepito come "poco problematico" dal momento che ai soggetti in età senile viene attribuita, dagli adolescenti, maggiore maturità, superamento delle preoccupazioni estetiche e una sempre crescente indipendenza dai giudizi altrui.

null
Prevenzione e/è comunicazione? Uno studio sul consumo tabagico tra gli adolescenti
Piazza A, Tullio V, Algeri D, Russo M, Zaoner L.
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Palermo
-
La maggior parte degli interventi di promozione della salute e di prevenzione primaria e secondaria si basa sulla comunicazione. Comunicare, però, non significa esclusivamente informare, ma anche e soprattutto "ascoltare", il punto di vista dell'altro cui ci si rivolge. La conoscenza dei danni causati dal fumo delle sigarette sulla salute sono oggi noti alla maggior parte delle persone; numerose campagne sanitarie e di informazione e iniziative legislative confermano negli ultimi anni una massiccia lotta al tabagismo. Gli studi sull'efficacia degli interventi di prevenzione primaria e secondaria del tabagismo nella popolazione giovanile evidenziano, però, risultati che contrastano con l'impegno e la vastità degli interventi stessi. Il consumo tabagico continua infatti a essere un fenomeno diffuso e in costante crescita nei paesi in via di sviluppo e nei paesi occidentali, soprattutto nelle popolazioni giovanili e nei soggetti di sesso femminile. Finalità della presenre ricerca era lo studio dei modelli di intervento impiegati nelle azioni di prevenzione primaria e secondaria dell'abitudine tabagica. Si è partiti dall'ipotesi che le azioni di prevenzione del consumo tabagico e/o di interruzione dello stesso non tengano conto delle rappresentazioni sociali relative al consumo di sigarette del target di soggetti destinatari degli interventi, e siano dunque incapaci di entrare in reale comunicazione con questi stessi soggetti. Attraverso il coinvolgimento di circa 400 adolescenti, il ricorso a questionari autosomministrati e focus group e l'osservazione clinica, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: l'esplorazione delle rappresentazioni sociali degli adolescenri sul fumo; l'esplorazione dei modelli di salute veicolati dagli interventi di prevenzione/riduzione del tabagismo. I risultati hanno consentito di evidenziare l'esistenza di alcune criticità centrate sulla presenza di uno scarto tra le rappresentazioni sottese alla modellistica degli interventi di prevenzione primaria del tabagismo e l'immaginario degli adolescenti.
Vite di cristallo: l'identità psicocorporea in soggetti emofilici
Piazza A, Oteri S, Schimmenti A, Russo M, Giannì G.
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Palermo
-
L'emofilia è una patologia diaginica-oloandrica che, a causa di un carente funzionamento del fattore di coagulazione , comporta processi emorragici di diversa rilevanza clinica e talora mortali (come nel caso di ictus cerebrali); essi provocano nella maggior parte degli episodi un riversamento ematico a carico dei tessuti interni e delle articolazioni, con gravi e invalidanti ripercussioni sull' integrità corporea. I soggetti emofilici, spesso sin dalle primissime fasi dello sviluppo, sono permeati da perturbanti processi somatici degenerativi che condizionano profondamente la costruzione dell'identità psicocorporea. I confini somatici, così violati e penetrati dalla stessa sostanza fluida che generalmente costituisce la fonte di vita, subiscono modificazioni decisive, tanto da incidere profondamente anche sugli aspetti psichici e relazionali. In una prospettiva teorico-epistemologica di tipo olistico, riteniamo che tra la dimesione corporea e quella psichica vi sia un continuo e reciproco rispecchiamento e pertanto siamo convinti che malattie così pervasive e totalizzanti come l'emofilia non possano non influenzare in modo significativo i processi psicodinarnici intra- e interpersonali dei soggetti che ne sono affetti. Nel caso dell'emofilia, il sangue possiede molteplici e controversi aspetti simbolici legati al suo potere vitale e mortifero. Questa complessità implica un continuo e difficoltoso processo di elaborazione e significazione della sofferenza esperita, che deve essere necessariamente supportato con vicinanza empatica non solo dalle figure familiari, nei confronti delle quali talvolta esistono forti sentimenti di rabbia e ambivalenza affettiva, ma anche dall'équipe di cura, che diviene garante della salute fisica e di un'integrità identitaria di "cristallo", spesso vissuta come fatalmente fragile.